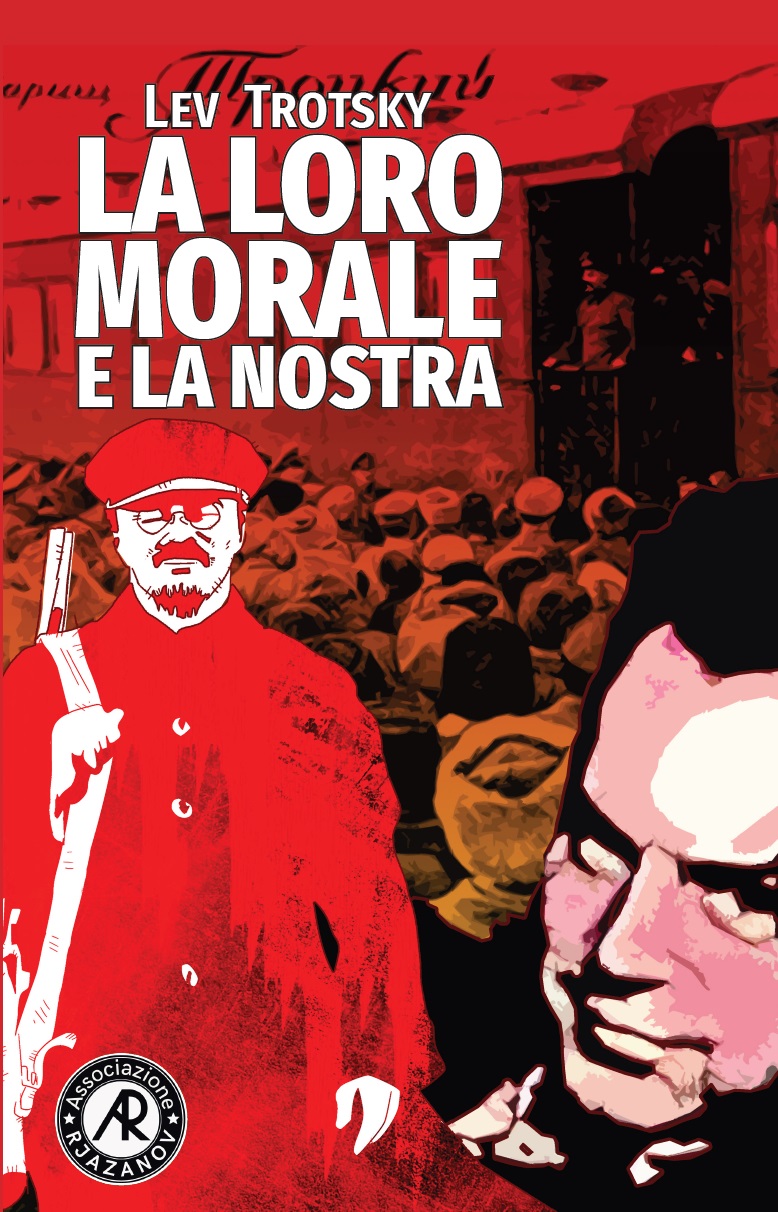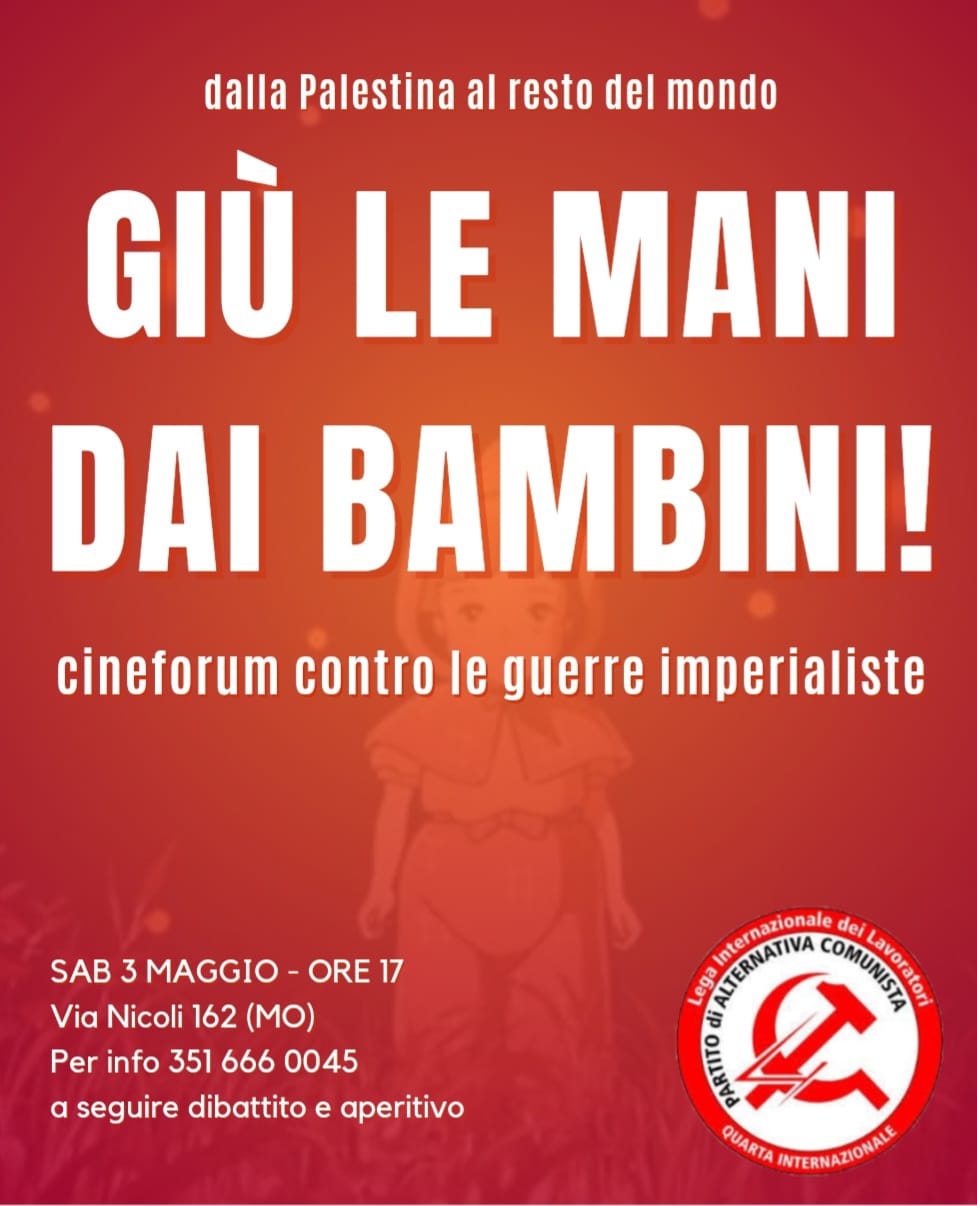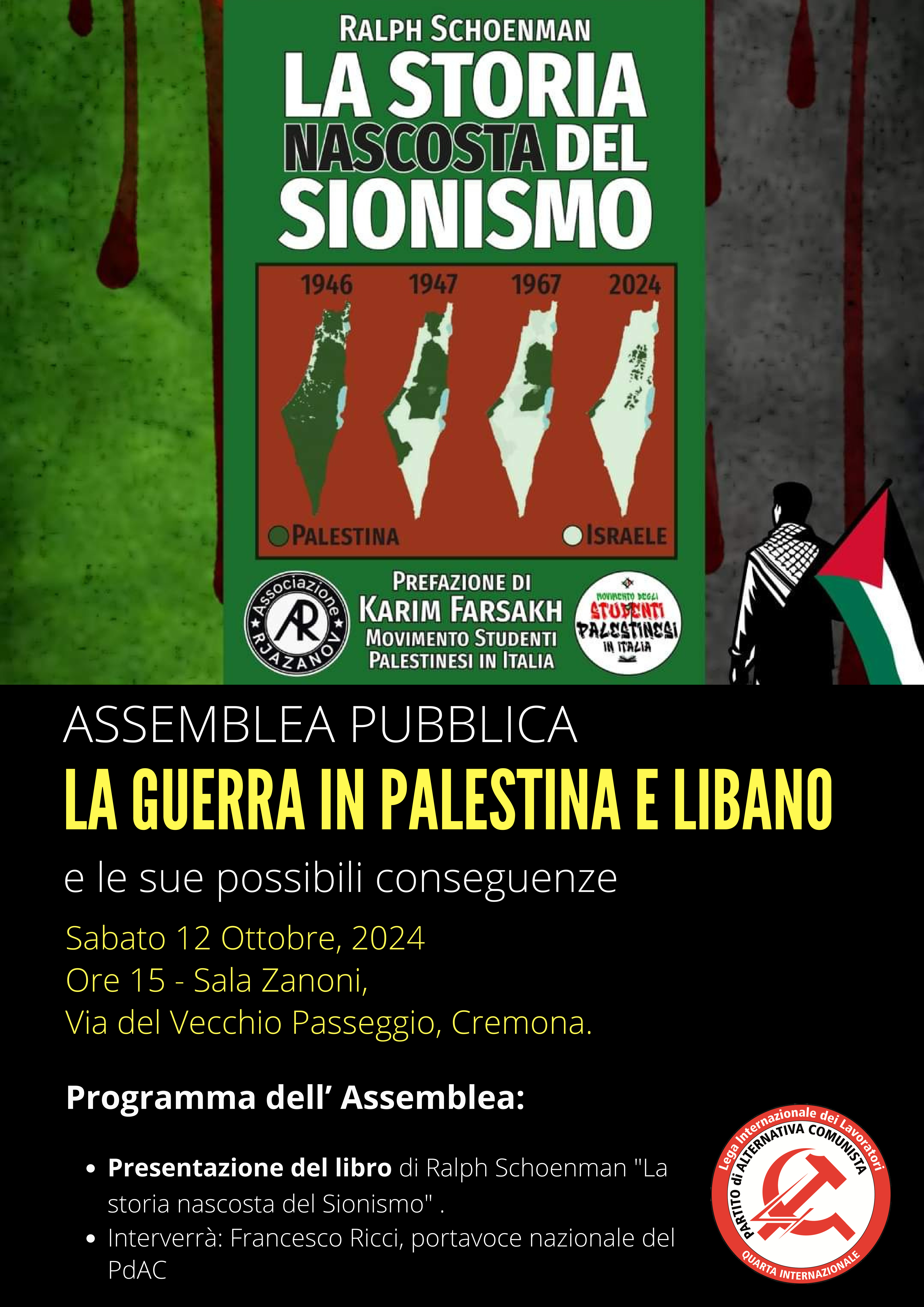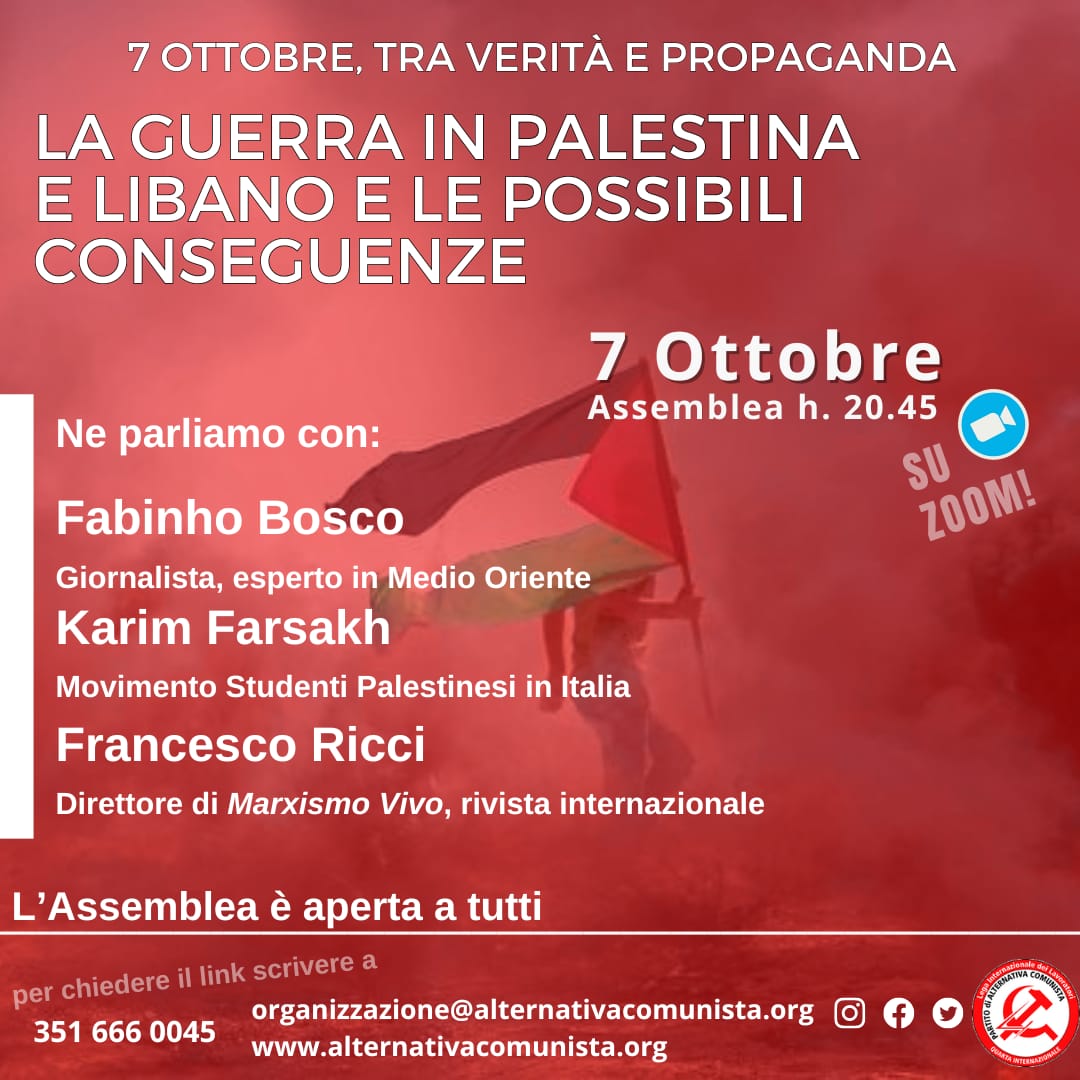La crisi del capitalismo continua a produrre
i suoi effetti brutali
di Alberto Madoglio
L’annuncio fatto qualche giorno fa dall’amministratore delegato di Unicredit, il francese Jean Pierre Mustier, relativo a una nuova tranche di esuberi nel secondo gruppo bancario italiano, pari a 8.000 lavoratori, per i 2/3 ubicati in Italia, ha sollevato un coro di polemiche e critiche. C'è da dire che il modo in cui è stato fatto l’annuncio (8.000 esuberi e 8 miliardi di utile da distribuire ai soci) non è certo stato il massimo dal punto di vista comunicativo. Questo la dice lunga sia sulle capacità di marketing degli alti papaveri del capitalismo, sia dell’arroganza e, se vogliamo, del senso di onnipotenza che caratterizza le classi dirigenti nostrane ma non solo.
Migliaia di lavoratori sacrificati sull'altare del profitto
Il piano strategico «team 23» (questa è la sua denominazione ufficiale) non è certo una novità per l’istituto di credito, passato in poco più di un decennio da 174 mila a circa 87 mila dipendenti, un calo del 50%, solo in parte dovuto alla cessione di alcuni asset aziendali. Nel recente passato alcuni dei tagli più consistenti avevano riguardato le partecipate estere della banca (Germania e Austria), senza causare lo stesso clamore nella politica e nei mass media. Ma si sa, se si licenzia all’estero, per molti sovranisti nostrani, sia di centrodestra che di centrosinistra, non è una cosa di cui dolersi troppo, anzi è sintomo della «modernità» della finanza e dell’industria tricolori.
Per cercare di calmare gli animi, Mustier ha affermato che, crediamo almeno per i lavoratori in Italia, i tagli saranno socialmente sostenibili. Fuor di metafora, intende che non verranno fatti licenziamenti ma si ricorrerà, come in passato, al prepensionamento.
A prima vista si potrebbe salutare positivamente questa decisione, Qualcuno potrebbe dire: «ma se siete per la riduzione dell’età pensionabile, cosa vi lamentate in questo caso?».
Le cose sono però diverse. Prima di tutto noi rivendichiamo un diritto generalizzato per tutti i lavoratori e non una «concessione» fatta dai padroni quando e se conviene a loro.
Inoltre in questo caso non si tratta di un vero prepensionamento. Nel periodo transitorio fino al raggiungimento del diritto di quiescenza, l’assegno non viene rivalutato, non garantisce il diritto alla reversibilità, i contributi pensionistici sono «figurativi», quindi è possibile che la pensione maturata sia più bassa rispetto a quella maturata se si rimanesse al lavoro.
Inoltre da qualche anno il fondo esubero per i lavoratori è in parte finanziato dallo Stato tramite l’Inps. Sappiamo cosa questo porterà. Si dirà che il sistema pensionistico costa troppo, i conti non sono in ordine, quindi è necessaria una nuova riforma, meglio una controriforma. Come al solito i lavoratori pagheranno per le pretese dei padroni.
Ma cosa ha spinto la banca a varare l’ultimo, per il momento, di una lunga serie di tagli al personale?
Nell’ultimo anno (2018) le banche tricolori hanno prodotto circa 10 miliardi di utile, il che spinge a ritenere incomprensibili tagli del personale di queste dimensioni. Tuttavia anche gli istituti di credito, come ogni altro settore dell’economia mondiale, sono stati colpiti dagli effetti della crisi economica scoppiata nel 2007. Se consideriamo che altre nubi si addensano all’orizzonte economico, e che la concorrenza tra colossi finanziari diventa sempre più brutale, ecco che la scelta della banca ha una sua logica, per quanto perversa ci appaia. Non vogliamo ovviamente dare nessuna attenuante o giustificare la decisione, solo cercare di spiegare che questa non è dovuta alla mancanza di sensibilità di un manager che deve rispondere alle pretese di azionisti sempre più avidi, ma solo spiegare che è la logica stessa, intrinseca di un sistema basato sul profitto, che conduce a scelte disumane.
La crisi cova nel cuore del sistema finanziario
Un’analisi prodotta la scorsa estate dal centro studi di Mediobanca, fornisce un quadro interessante sullo stato del sistema finanziario globale.(1) È un’analisi molto approfondita (oltre 180 pagine) che abbraccia un arco di tempo che va dal 2007 al 2018. Raffronta la situazione delle banche di Usa, Europa, Giappone e Cina. Per l’economia del nostro scritto, ci interessiamo solo del confronto Usa-Europa.
La produttività del lavoro, nelle banche statunitensi, è aumentata nel periodo preso in esame del 18%, a fronte del 7% del Vecchio Continente. Per entrambe le aree il costo del lavoro è aumentato del 24%. Questo ci fa presumere che anche nel settore del credito, come per l’industria in generale, ci sono scarsi investimenti in capitale produttivo.(2) Ciò che spinge i padroni a investire sono la percentuale e la massa dei profitti rispetto a quanto investito in capitale «morto» (macchinari), «vivo» (salariati) e materie prime. Se i profitti nell’economia «reale» sono in calo (come avviene da lungo tempo, almeno dal 1997, momento in cui si è raggiunto il picco, in seguito mai più eguagliato), i padroni anziché investire nella produzione vera e propria, tentano di ottenere profitti extra ricorrendo alla speculazione, di qualunque tipo (finanziaria, di borse, legata al settore immobiliare, ecc.).(3)
I crediti dubbi sul totale ammontano allo 0,4% negli Usa e al 2,4% in Europa. Il livello di copertura per questi (garanzia per semplificare) è 84% contro il 50%. Gli investimenti in titoli strutturati, più rischiosi ma più redditizi, sono il 39% e il 5%.
Le banche americane hanno reso l’85% dei fondi statali ottenuti nel periodo più acuto della crisi, contro il 57% delle europee. Questo la dice lunga sulla natura più attenta all’interesse comune del capitalismo europeo: prima vengono gli utili da distribuire agli azionisti, poi se avanza qualcosa si restituiscono gli aiuti pubblici, che sia detto di passata, per essere stati forniti alle banche sono stati tolti alle spese per lo stato sociale (scuola, sanità, pensioni).
La crescita degli attivi bancari è stata rispettivamente del 63% e dell’1,6%, la redditività del capitale del 7,5% contro il 6,3%.
Tutti questi dati ci portano a una conclusione. Le banche europee sono, complessivamente, più deboli rispetto alle loro concorrenti oltre Atlantico. E le banche italiane sono, a loro volta, più deboli tra quelle europee.
Nella lista delle prime 10 banche europee che hanno controllate in Usa, che ricordiamo essere mercato più redditizio, nessuna è italiana.
Come tentano di resistere alla concorrenza mondiale le banche del Belpaese? Applicando una dura ricetta di riduzione del costo del personale. Il costo medio per dipendente è, in termini assoluti, il più basso livello continentale, superato solo da quello dello Stato spagnolo (e in termini relativi 5 punti percentuali sotto la media). Non è un caso che l’aumento del costo del lavoro per le banche nostrane sia stato di 4 punti inferiore (20 contro 24%).
Unicredit non sfugge a questo quadro di estrema fragilità. Per migliorare i propri conti non solo ha dimezzato il personale, ma ha dovuto fare cessioni di attività, alcune delle quali redditizie (risparmio gestito), riducendo quindi la possibilità di fare maggiori utili in futuro. Tra il 2013 e il 2017 è stata tra le banche europee che ha avuto tra le percentuali più alte di crediti dubbi e di conseguenza ha dovuto fare forti svalutazioni del loro valore. Le entrate extra ottenute con cessioni di attività non sono state sufficienti. Si sono resi necessari ben quattro aumenti di capitale dal 2008 a oggi, pari a 27,5 miliardi di euro. A oggi la banca ha un valore di borsa di circa 28 miliardi. Gli aumenti chiesti agli azionisti si sono, in poche parole, polverizzati. Infine, i due mercati maggiori in cui la banca opera sono uno, l’Italia, in recessione da anni, l’altro, la Germania, caratterizzato da preoccupanti dati di rallentamento.
Un peggioramento del quadro economico industriale non potrà non avere ripercussioni su tutte le istituzioni bancarie lì coinvolte.
Si avvicina la resa dei conti tra Capitale e Lavoro
Immaginiamo che queste cifre possano aver frastornato il lettore, ma ci è sembrato utile elencarle per cercare di rendere chiaro il contesto in cui ci troviamo.
Per noi risulta chiaro quanto sia assolutamente illusorio chiedere alla banca di tornare sui suoi passi. Chi ha perso 27 miliardi di valore in dieci anni, non si farà certo scrupoli a provare a rifarsi sulle spalle di 8.000 lavoratori.
Un editorialista de IlSole24Ore poneva una domanda: «Vogliamo che Unicredit continui a competere sul mercato mondiale o vogliano che svolga un ruolo di ammortizzatore sociale?». L’editorialista, che ovviamente opta per la prima ipotesi, nella sua schiettezza ha detto una cosa giusta. In un mondo basato sul guadagno i profitti vengono prima e i lavoratori per ultimi.
La lotta contro gli esuberi in Unicredit, così come contro quelli di Alitalia, Ilva, Whirpool e delle centinaia di crisi aziendali in corso e alle centinaia che verranno, ha una possibilità di essere vinta solo se mette in discussione il capitalismo in quanto tale.
Nei decenni scorsi, quando il capitalismo aveva delle briciole da concedere ai lavoratori, si poteva far credere che padroni e lavoratori avessero interessi comuni e potessero arrivare a compromessi dignitosi per entrambi.
Chi oggi, burocrati sindacali in testa, rilancia questa ipotesi, non è un illuso utopista ma un pericoloso nemico di quei lavoratori che a parole afferma di voler difendere.
A noi non interessa il fatto che in oltre un decennio di crisi economica, anche qualche padrone abbia subito delle perdite. Non ci schieriamo a fianco dei padroni italiani contro quelli stranieri, né vagheggiamo di alleanze tra i «produttori» per salvare un sistema che ha dimostrato il proprio fallimento oltre ogni ragionevole dubbio.
Oggi più che mai un altro mondo, un mondo socialista, non solo è possibile ma necessario.
Note
1) Dati cumulativi delle principali banche internazionali e piani di stabilizzazione finanziaria. Indagine annuale 2019, www.mbres.it
2) Per quanto riguarda le banche, sarebbe più corretto parlare di appropriazione di plusvalore creato dall’industria. Anche in questo caso la composizione organica del capitale c/v è fondamentale per aumentare la porzione di plusvalore che viene ottenuta a spese dei concorrenti.
3) Per approfondire il tema suggeriamo la lettura del libro di Michael Roberts The Long Depression. How it happened, why it happened and what happens next, Haymarketbook 2016, e in particolare il capitolo 13 “Falling productivity growth”, p. 239.