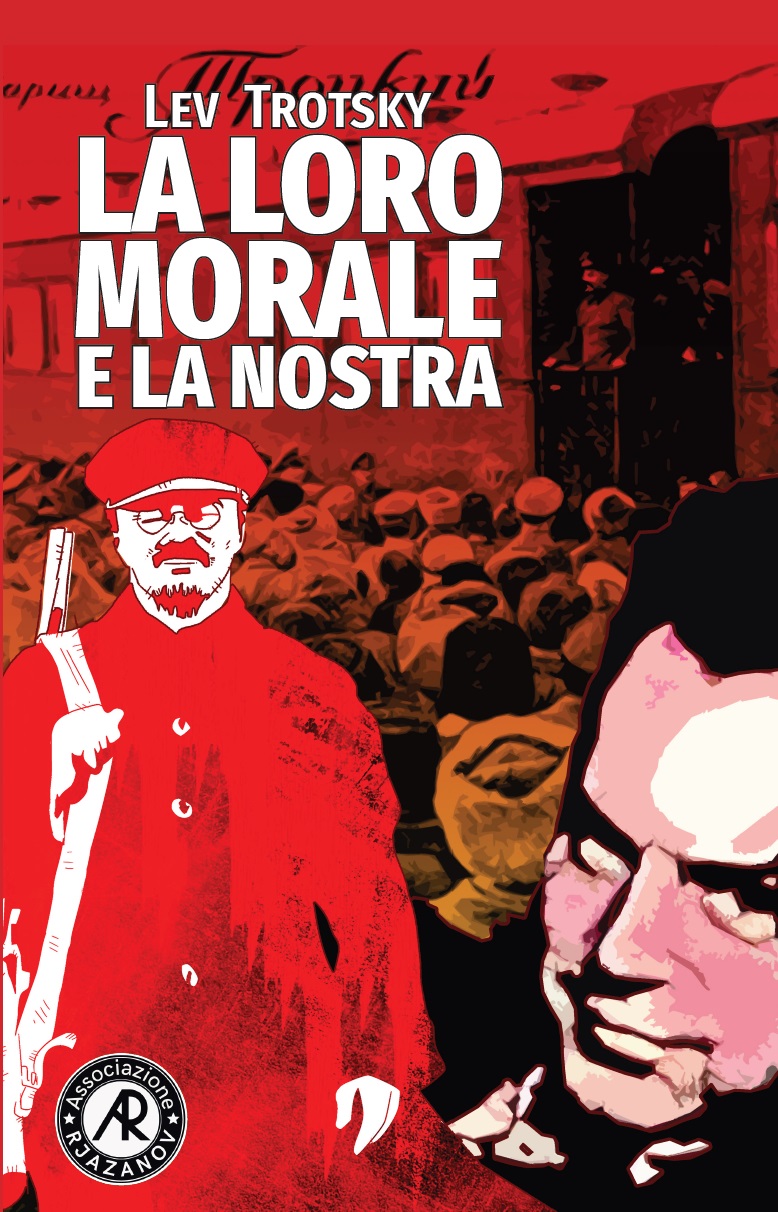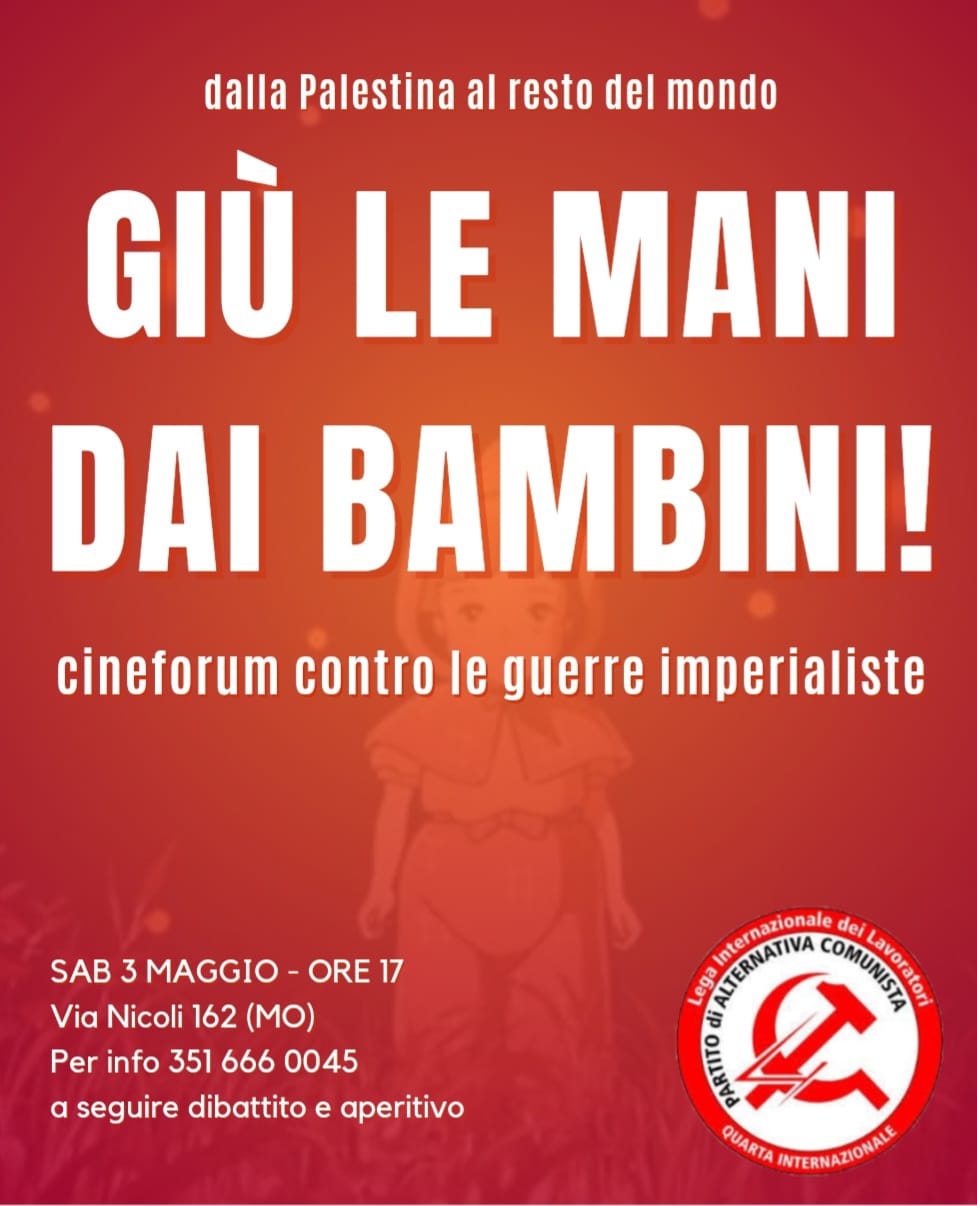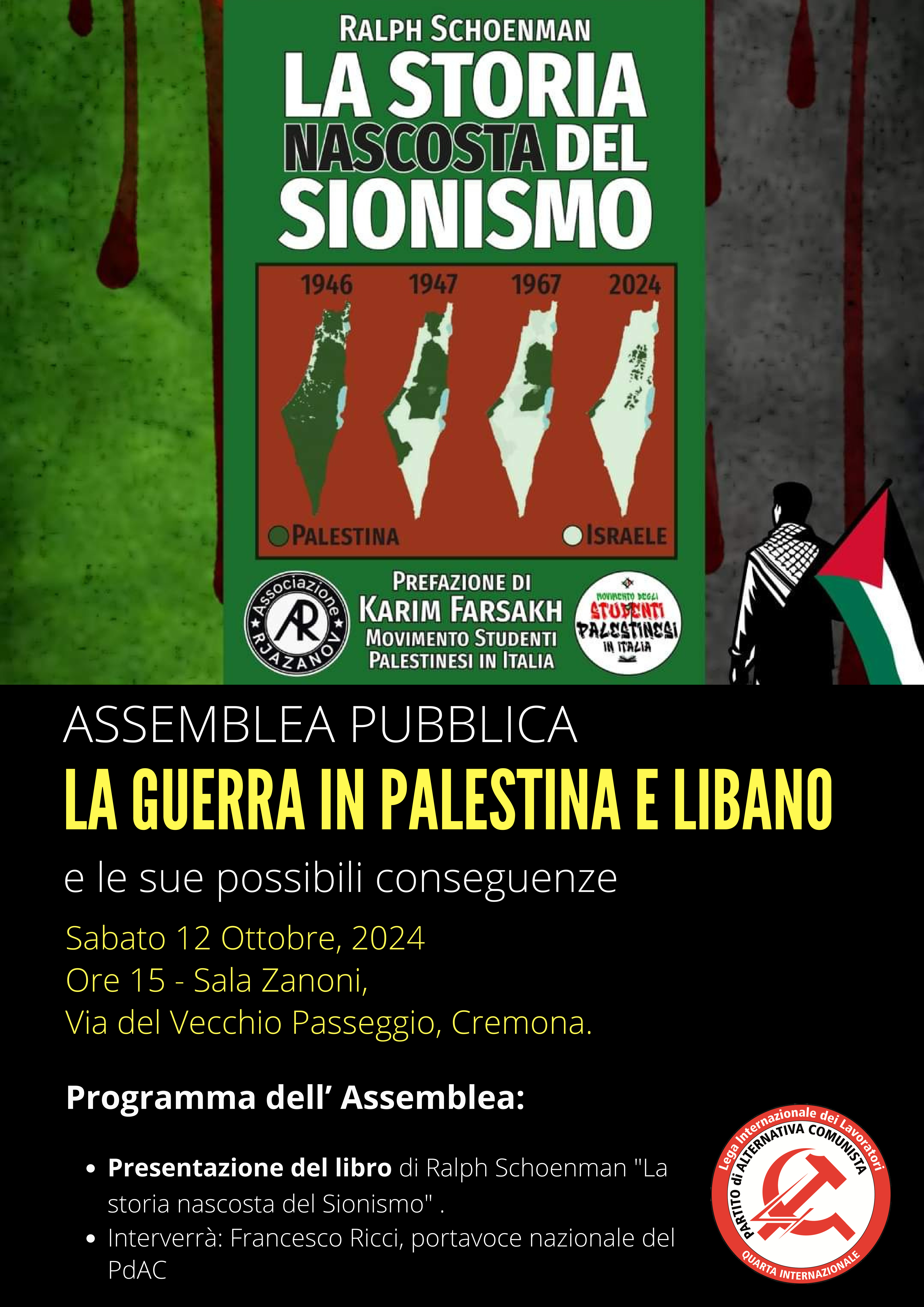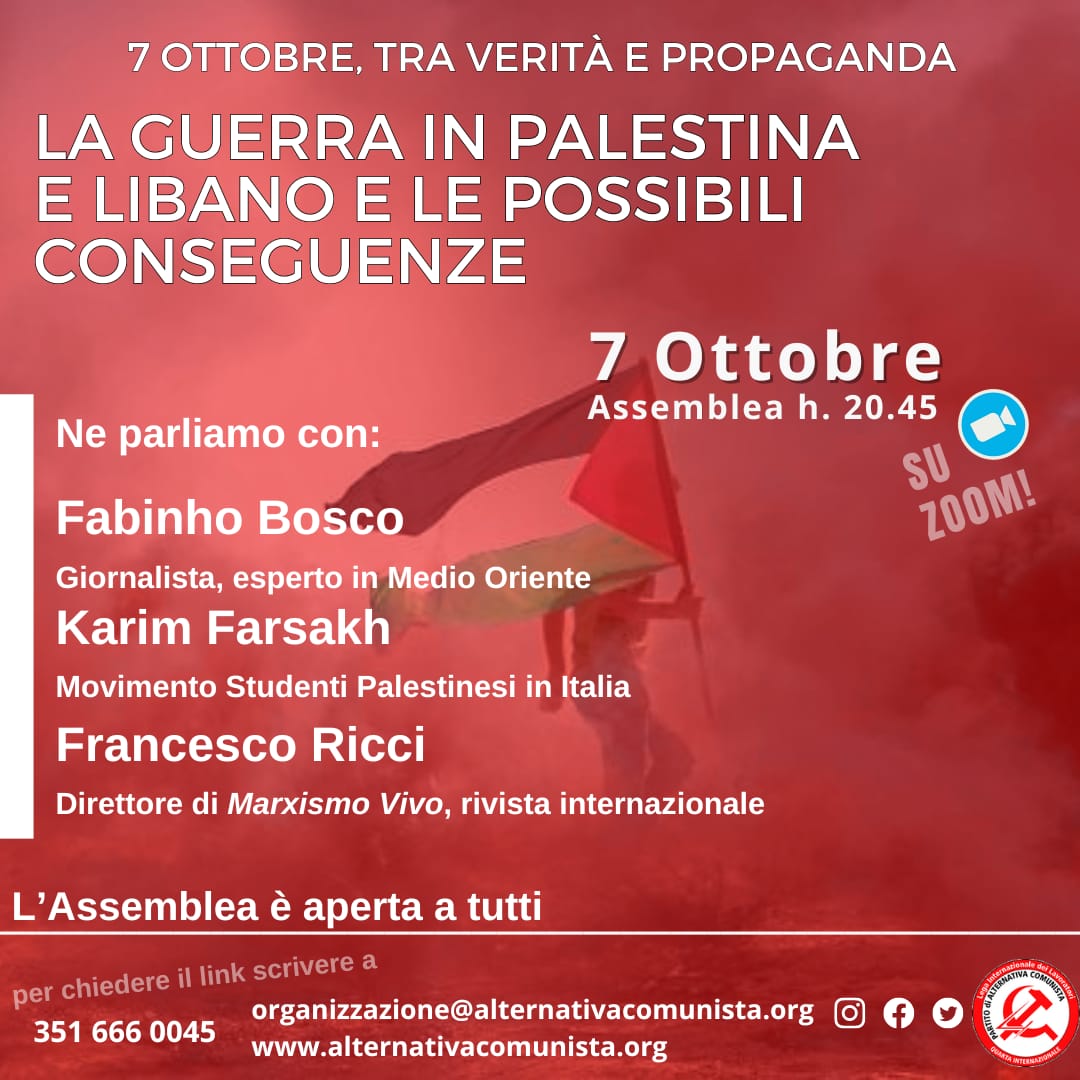La scienza è democratica?
di Giorgio Viganò
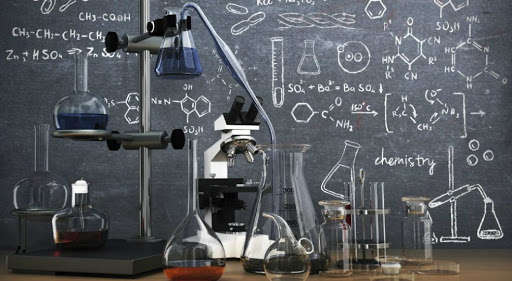
Correva l’anno 2017 quando Roberto Burioni, nel corso della polemica sui vaccini innescata dai quasi 5000 casi italiani di morbillo di quell’anno e organizzata attorno all’entrata in vigore dell’obbligatorietà di dieci diverse immunoprofilassi, pubblicò «La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica», un libro che si occupa di riassumere la storia delle vaccinazioni e smontare le tesi antivacciniste: di per sé opinioni largamente condivisibili. La discussione con i No Vax sarebbe molto semplice da condurre se non si avesse a che fare con il complesso psicotico collettivo che connota la qualunque di complottismo. D’altro canto, ciò che è molto pericoloso è l’approccio dello stesso virologo quando afferma in apertura del suo blog MedicalFacts: la scienza non è democratica. «Una palla di ferro gettata in mare andrebbe invariabilmente a fondo, anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore a quello dell’acqua» (1): incredibile, esiste la realtà!
Pandemia e discorso medico-scientifico
Con l’avvento della pandemia, il discorso medico-scientifico si è imposto fisiologicamente come discorso collettivo, incrementando un’abitudine pregressa: persone non preparate tecnicamente danno delle proprie opinioni su scoperte scientifiche, sanitarie ecc. rendendolo un argomento da bar al pari di una discussione sugli attaccanti della Serie A; di riflesso, molti medici e biologi sono assurti a personaggi pubblici e politici e predicano in qualità di ospiti d’onore dei salotti televisivi, piegando le proprie opinioni - chi più, chi meno - alle necessità dei padroni da cui essi dipendono oppure a quella pura vanità che spesso insorge in chi, dapprima ignoto professionista, si ritrova repentinamente investito di celebrità.
Ora, già le fluttuazioni espresse da questa nuova classe di opinionisti mettono in evidenza quanto fosse ridicola la faciloneria della «palla di ferro»: è evidente sia che la scienza deve farsi strada tra molti dubbi per definire una verità, sia che essa, calata nel contesto sociale, affianca politica ed economia più come copertura che come guida.
Ciò accade specialmente in ambito medico e su questo si sofferma l’articolo, sia perché è l’unico in cui chi scrive ha le competenze per dare dati a sufficienza ma anche per la centralità attuale e futura della medicina, che si appresta ad affrontare l’epoca pandemica appena incominciata e che viene già da tempo riconosciuta come uno dei campi principali in cui si sviluppa il progresso tecnologico e produttivo della società.
Proprio per questo, un ruolo centrale della scienza nei processi decisionali sarebbe un fatto solamente: il timore nei confronti della scienza è un carattere oscurantista, che per nulla compete ai marxisti. Inoltre, il protagonismo delle masse popolari in tale ambito non è un problema, ma anzi è la soluzione per permettere la centralità della scienza in politica, come concludono diversi studiosi che hanno affrontato la questione pur rimanendo nell’ottica del sistema capitalista (ad esempio Mauro Dorato, Disinformazione scientifica e democrazia, 2019).
È, appunto, la funzione che le istituzioni medico-scientifiche e i loro vari protagonisti svolgono da sempre in questo sistema a legittimare l’approccio autoritario e denigratorio che Burioni non si cura nemmeno di celare. Sono sia il capitalismo in sé sia il ruolo della scienza nel sistema sia l’approccio che vari suoi rappresentanti usano a fomentare la sfiducia e a deviare i giusti pensieri critici di parte della popolazione verso il complottismo, che per definizione è sterile nella critica in quanto trasferisce la propria arena nel campo dell’irrealtà.
Scienza e verità
La possibilità della scienza di formulare predicati di verità è un tema filosofico che non può essere banalizzato. Questo tema possiede una storia nobile quantomeno a partire da Galileo e una centralità sia nella filosofia del Novecento sia in quella del nuovo millennio, con protagonisti, tra gli altri, i noti Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell e, in Italia, Ludovico Geymonat e Nicola Abbagnano. Questo non è un articolo di epistemologia, ma si ricordano questi nomi per evidenziare la complessità del tema, mentre ci si focalizzerà brevemente su alcune annotazioni tecniche e sulle modalità pratiche con cui viene svolta la ricerca biomedica.
Esistono due tipologie di ricerca: quella di base, che si occupa d’indagare un determinato fenomeno in maniera - per così dire - disinteressata, e quella applicata, in cui si cerca una soluzione ad un problema. È la differenza che passa tra il sequenziamento del genoma dei Siv (i parenti scimmieschi dell’Hiv, molto interessanti per il fatto che perlopiù non causano malattia nei loro ospiti) e lo studio di possibili bersagli di vaccini presenti nella struttura dell’Hiv. Sono due componenti ugualmente importanti della scienza in generale: la ricerca di base, seppur possa apparire a un primo sguardo inutile, accademica e oziosa, in realtà apre strade sia nel momento in cui viene svolta - motivo per cui si afferma spesso che le vere scoperte vengano dalla buona ricerca di base - sia quando affiorano sfide inaspettate, divenendo un bacino a cui attingere in momenti di difficoltà; ciononostante, per quella prima impressione di inutilità a cui quasi sempre si ferma la volgarità del capitalismo, i fondi per la ricerca di base sono ridotti al lumicino, riducendo di molto le possibilità dello sviluppo scientifico dell’umanità.
Dunque, la ricerca biomedica inizia comprendendo le basi biologiche di un fenomeno e individuando le modalità in cui sia possibile modificarlo a favore dell’uomo e gli strumenti con cui fare ciò, ossia le molecole che costituiranno i farmaci.
Definita l’efficacia dell’approccio scelto in vitro, cioè facendo dei test su cellule astratte dalla complessità di un organismo vivente, si approda alla sperimentazione in vivo, in primo luogo sugli (altri) animali: questo, per inciso, è un passaggio fondamentale, in quanto permette di poter commettere errori difficilmente prevenibili (si è studiata l’efficacia della molecola farmacologica sul bersaglio del processo patologico, ma in vitro non è presente un fegato che possa soffrirne in maniera collaterale, come spesso accade) e ricreare - geneticamente e non - le condizioni della patologia studiata in modelli non umani, che pure devono essere trattati, stando ai protocolli, nella maniera più etica possibile; essere contro a priori all’utilizzo degli animali in sperimentazione è una tendenza oscurantista fortunatamente un po’ demodé e che per giunta sottovaluta l’utilità della stessa ricerca per la salute degli animali, in quanto spesso le malattie che ci affliggono sono le stesse.
Se si hanno buone risposte nell’animale, si passa alla sperimentazione clinica in tre fasi, in cui si allarga man mano la platea di pazienti ingaggiati nel trial e si modificano gli obiettivi: nella prima la tollerabilità nell’uomo, nella seconda l’efficacia e il profilo degli effetti collaterali, nella terza la superiorità del farmaco sperimentale rispetto a quello precedentemente in uso o, nei casi in cui non esista, a un placebo.
Nel percorso di questo studio, che viene chiamato “prospettico” nella sua parte dedicata all’uomo e che offre un esempio chiaro di applicazione della ricerca scientifica, sono molti gli ostacoli che rendono difficile tirare le conclusioni, che solo raramente sono talmente chiare, ad esempio, da far concludere anticipatamente la sperimentazione per una chiara immoralità nel somministrare il placebo a un malato.
Innanzitutto, nella preparazione dello studio bisogna definire tre grosse questioni. La prima è la coorte che s’intende prendere in esame, che deve rispondere a criteri d’inclusione prestabiliti e che dev’essere divisa in gruppi il più possibile omogenei (per sesso, età, gravità della malattia e qualsiasi altro fattore prognostico noto), sebbene questa omogeneità sia sempre soltanto un’approssimazione, essendo effettivamente ogni persona e ogni malattia differente nella risposta ad una terapia; la seconda è la modalità di svolgimento dell’indagine, tra le quali quella più performante nella riduzione dell’errore di valutazione è quella del trial randomizzato controllato in doppio cieco, in cui si «randomizza», ossia si distribuisce casualmente la popolazione in esame tra i due o più gruppi, si “controlla”, ossia si crea almeno un gruppo «di controllo» a cui viene assegnato il vecchio farmaco o il placebo, e si impedisce di conoscere quale trattamento venga somministrato sia al paziente che al medico («doppio cieco»), per non influenzare il comportamento dell’uno e la valutazione dell’altro: questo passaggio è, ovviamente, quello più soggetto ad infrazioni; la terza è il profilo degli outcome, ossia delle informazioni che si vogliono registrare a distanza di un certo tempo dall’inizio della terapia, le domande a cui si vuole rispondere: ad esempio, se ci sia un guadagno nella sopravvivenza a 6 mesi.
Si vanno, infine, a raccogliere i risultati, che saranno tanto più diversi quanto più si estende la popolazione in studio: è, quindi, necessario usare un insieme di operazioni statistiche specifiche per generare dei dati e comprendere il loro significato, la loro affidabilità e la loro significatività. Si utilizzano delle operazioni correttive (ad esempio, per contrastare l’effetto di una popolazione troppo ristretta) e sono usati indici per comprendere se il risultato congruo con l’ipotesi di partenza sia casuale o meno (la «significatività»). Uno degli indicatori più chiari è il rapporto di rischio (più conosciuto come hazard ratio), che è il rapporto tra i tassi di rischio (di mortalità, complicanze, infezione) nel braccio sperimentale (quello, ad esempio, che assume il nuovo farmaco) e nel braccio di controllo: esso dev’essere minore di 1 per deporre a favore della terapia in sperimentazione, in quanto significherebbe un minor rischio usando questa rispetto a quella precedente o al placebo. Tuttavia ciò non basta, in quanto potrebbe essere che quella a godere di questo beneficio sia una parte di popolazione che non rappresenta la popolazione generale, ma una fetta che, casualmente, ha una predisposizione naturale alla guarigione in assoluto o anche solamente in relazione al farmaco usato: perciò il risultato dev’essere sottoposto ad un’operazione statistica che solitamente produce gli estremi dell’intervallo (detto «di confidenza») in cui c’è il 95% di probabilità di trovare il vero dato ricercato, rendendo non significativo qualsiasi risultato il cui intervallo comprenda l’1, che rappresenta l’equivalenza tra le opzioni in campo.
A proposito dei vaccini
Questa trattazione certamente riassuntiva, ma che spero possa essere stata utile per comprendere le mosse generali del metodo che ha portato - ad esempio - all’approvazione dei vari vaccini anti-Covid, mira ad illustrare quanto sia difficile produrre dei dati di verità quando ci si relazione con la complessità dell’essere umano. E se i labirinti della statistica sono i principali ostacoli nel campo della ricerca clinica, il problema fondamentale in tutto ciò che la precede, dalla ricerca di base alla sperimentazione in vitro, è la frammentarietà delle conclusioni a cui si arriva con i singoli esperimenti: è possibile avere un risultato in certe condizioni sperimentali e al risultato opposto cambiandole; motivo per cui è necessario provare e riprovare, costruire il dato di verità integrando diversi studi, spesso di gruppi di ricerca differenti. Perciò, è fondamentale il confronto all’interno della comunità scientifica e la revisione tra pari, ossia il controllo incrociato tra professionisti di diverse istituzioni, rappresenta il sine qua non per uno studio affidabile.
Considerato ciò, il ruolo dell’autorità scientifica, ossia la fama e il prestigio, anche meritati, degli studiosi o dei singoli centri di ricerca, non vale alcunché. Se si delega ai principi citati poc’anzi, il risultato è quello ben esemplificato da una buffa pubblicazione a prima firma di Jean-Pierre Changeux, pluripremiato neurofisiologo francese, che l’anno scorso ha proposto di trattare il Covid con la nicotina mettendo insieme una serie di risultati decontestualizzati come la presunta protezione dei fumatori contro il virus (una suggestione dei primi mesi della pandemia, poi smentita da ulteriori studi) e la somiglianza tra una proteina del Coronavirus e la tossina del cobra, il tutto pubblicato su una rivista esente da revisione tra pari (2).
La pubblicazione vale l’aggettivo di «buffa» perché, per fortuna, per come è stata costruita non può incidere in alcun modo sulle linee guida dei pazienti Covid e può al limite semplicemente stuzzicare il dibattito pubblico, come hanno fatto le tesi complottiste - questa volta senza nemmeno l’ingegno di un articolo scientifico, per quanto surreale - di Luc Montagnier, premio Nobel e vero scopritore dell’Hiv, sulla produzione in laboratorio e la diffusione tramite il 5G del Sars-CoV-2. Queste teorie, se così vogliamo chiamarle, creano una possibilità di deviare la coscienza delle masse, ma non hanno nessuna ricaduta pratica nell’ambito prettamente medico.
Il motivo è che la discussione politica, anche pensando ad una popolazione altamente istruita (o, come dicono molti degli esperti del tema, «scientificamente alfabetizzata»), non può sostituire la prassi scientifica in quanto non ne usa i metodi, che sono quelli con cui, pur affannosamente, si producono dati di verità nel campo delle scienze naturali: perciò, per ritornare a Burioni, nessun referendum cambierà mai il peso specifico degli elementi, ma ciò non vuol dire che la scienza non debba essere democratica nei propri metodi, anzi il libero confronto dovrebbe essere un presupposto fondamentale per aumentare la probabilità di dire il vero.
D’altro canto, non si può, soprattutto oggigiorno, liquidare così la questione: è sotto gli occhi di tutti che il dibattito pubblico può effettivamente interferire non tanto con la produzione della verità scientifica, quanto con il suo impiego operativo, che è quanto fanno attualmente i No Vax.
Effettivamente, la scienza non è democratica
In ogni caso, l’approccio altezzoso ed esclusivo in relazione ai dubbi delle masse non è nato con la pandemia, né con i libri di Burioni, ma è proprio di una percentuale importante dell’intellighenzia scientifica e rappresenta l’atteggiamento che meglio si sposa con la funzione della scienza nel capitalismo, difendendone il ruolo corrotto in un fortino difficilmente accessibile, soprattutto nei suoi centri e posizioni strategici.
I personaggi di questa élite insultano i non professionisti della scienza definendoli ignoranti, ma giovano dell’ignoranza del proletariato in un altro senso rispetto a quello che vorrebbero intendere, quando affermano che la scienza non è democratica: effettivamente, la scienza, intesa come istituzioni scientifiche, non è democratica.
E, sempre rimanendo in campo medico, come potrebbe esserlo, quando la ricerca è condotta dalle multinazionali farmaceutiche o da istituti sostenuti non certo dai 5 x 1000, bensì dai colossi della finanza. Un esempio? L’Istituto Europeo di Oncologia, fondato da Umberto Veronesi, e nel cui capitale sociale si iscrivono, tra gli altri, Pirelli, Telecom, UnipolSai, Intesa San Paolo, Mediobanca e Bpm (3). La ricerca pubblica è notoriamente vessata da continui tagli e dipende quasi sempre nel concreto dall’investimento privato: ad esempio, Eni, che con i suoi laboratori è alla ricerca costante del greenwashing - per cui ha ricevuto anche (meno di un graffio) una multa massimale da cinque milioni (4) - appartiene allo Stato per meno di un quarto delle sue azioni, una privatizzazione avviata dal governo D’Alema I insieme a tante altre.
Ma anche nei casi d’impegno statale maggiore, come per esempio quella collegata all’esercito, poco cambia per la natura di classe dello Stato, che non è altro che l’organizzazione della borghesia: in questo sistema, la scienza è asservita, volenti o nolenti, agli interessi industriali e commerciali.
L’impronta di questo dominio si vede in ogni fase della ricerca. Per iniziare, nella definizione dei campi d’interesse, ambito in cui una delle maggiori recriminazioni - come già detto - deve andare sicuramente al disinteresse nella ricerca di base.
Ma, oltre a questo, gli esempi di crudeltà efferata nei confronti di intere categorie di malati sono diversi: ne cito due molto diversi.
La retinite pigmentosa è una malattia che può essere dovuta a deficit di vitamina A o essere congenita, dovuta a mutazioni geniche. I gruppi di ricerca della biologa Enrica Strettoi di Pisa e del biochimico Riccardo Ghidoni già due decenni fa hanno scoperto un derivato di un fungo, il myriocin, che ha dato subito buoni risultati sui topi però non è mai stato sviluppato in studi umani per mancanza di fondi, ossia mancanza d’interesse nei confronti di una malattia rara; recentemente, sono state approvate due terapie molto più costose rispetto ad un prodotto biologico, il myriocin, facilmente producibile in larga scala: il cosiddetto «occhio bionico», dal costo complessivo di circa 200.000 €, e il Luxturna, terapia genica che costa 800.000 € annui.
Qualche esempio significativo
L’Hiv, perdura ormai da quarant’anni, ha avuto gli effetti di una pandemia, con curva e diffusione del tutto diverse da quelle del Covid, ma che ha interessato circa 100 milioni di persone nel mondo, di cui almeno 36 milioni sono morte a causa dell’Aids, la terribile sindrome che si sviluppa tendenzialmente dopo 5-10 anni dall’infezione. Da più di un decennio, la speranza di vita media di un sieropositivo in Occidente è soltanto di qualche anno inferiore rispetto a quella della popolazione generale, un traguardo incredibile se si pensa che negli anni Ottanta la diagnosi, quasi sempre in stadi avanzati, anticipava una morte certa in pochi mesi. Questo indubbio successo della scienza medica è organizzato attorno ai farmaci antiretrovirali, il primo dei quali è stato immesso in commercio nel 1987, seguito da molti altri che attualmente vanno a definire una terapia combinata di base formata da 2-3 medicine. Queste hanno un’efficacia del 100% se assunte correttamente prima dell’esposizione al virus (ad esempio, un rapporto sessuale a rischio, che in Occidente è la modalità di trasmissione più comune) e possono sventare il successo dell’infezione anche dopo poche ore dal contatto con l’Hiv, ma il loro uso principale è quello che permette di azzerare la presenza del virus nel sangue («carica virale») e, in questo modo, impedire la progressione verso l’Aids e rendere il paziente non contagioso. Anche per questo impiego, la terapia va assunta correttamente e quotidianamente, perché purtroppo il virus si rifugia in distretti dell’organismo in cui è inattaccabile dai farmaci, dunque torna in azione se per un po’ (basta qualche giorno) si rimane scoperti: una terapia dai molteplici utilizzi e che, nel suo uso principale, è a vita. E che, anche solo per la durata, costa troppo per i Paesi del sud del mondo: in Europa e in Nordamerica, una persona su 2000 è sieropositiva, mentre in Africa si è attorno a una su 200, con circa 20000 morti per Aida all’anno sommando Europa e Nordamerica e circa 800000 in Africa.
Anche da organizzazioni istituzionali come l’Unaids sono giunte varie proteste nel corso degli anni nei confronti delle grandi multinazionali del farmaco, che non hanno mai profuso - a buon ragione, dal loro punto di vista - sforzi e risorse finanziarie nella ricerca di un vaccino, che ha raccolto solo poche decine di milioni in progetti assolutamente peregrini per l’entità del problema sanitario in questione, trincerandosi dietro una difficoltà tecnica specifica dell’Hiv che probabilmente esiste, ma non regge ad una tecnologia che oggigiorno riesce a produrre un (ottimo) vaccino in meno di un anno (5).
Come anticipato, anche i risultati dello studio effettuato possono essere modificati, tant’è che le inchieste sulla manipolazione di risultati scientifici sono numerose. Ad esempio, il professor Fusco, luminare dell’oncologia endocrinologica a cui va il merito di importanti scoperte - ad esempio sulla genetica del tumore alla tiroide - ha sul groppone almeno 50 articoli la cui falsificazione è risultata palese in numerose perizie e che gli sono serviti per conseguire milioni di euro di fondi. In Italia, tuttavia, non esiste pena per il reato di falso scientifico e nemmeno l’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha ritenuto di sanzionare in alcun modo formale la frode, nonostante vi sia una parte del suo regolamento che cita «in caso di comportamenti contrari agli standard di etica, rigore e buona condotta nella ricerca (…) gli enti presso cui si svolgono progetti finanziati da Airc devono condurre indagini e accertamenti e prendere provvedimenti» (6).
E nemmeno i fautori di ricerche «controcorrente», che di questi tempi spopolano, possono sentirsi molto meglio: avrete sentito parlare dei vaccini che causano autismo. Bene, la correlazione nasce dalla coincidenza tra l’età in cui si è sottoposti al vaccino contro Mpr (Morbillo, Parotite e Rosolia), che in Italia vede la somministrazione della prima dose appena dopo il primo anno di vita, con l’esordio clinico dell’autismo, che si manifesta quando il bambino acquisisce la parola e dovrebbe iniziare a entrare a piccoli passi nella socialità, cosa che non avviene in questa patologia. Nel 1998, sull’autorevole rivista Lancet fu pubblicato uno studio, eseguito su 12 (!) bambini, che indicava come possibile questa correlazione. Ingigantito da una conferenza stampa dell’autore, il gastroenterologo Andrew Wakefield, e dal tam-tam mediatico, questo dato non ebbe riscontro in numerosi studi eseguiti successivamente su numeri più ampi (fino all'analisi complessiva di 14 milioni di bambini in 27 trial differenti) (7). Nel 2009, un’inchiesta giornalistica appurò che i dati erano stati manipolati e il materiale manomesso in blocco: ad esempio, c’erano in ballo delle interpretazioni di biopsie coliche con minimi difetti interpretati come colite (l’ipotesi originaria era, infatti, quella di una sindrome consistente in autismo e problemi gastrointestinali). Un anno dopo, si capì il motivo d'un inganno così grossolano: 500.000 $ per sostenere la causa intentata da un’associazione di genitori di bambini autistici contro lo Stato e la creazione di una propria azienda che prevedeva di guadagnare «almeno 43 milioni all’anno» con lo sviluppo di test diagnostici per la «colite autistica», la malattia da lui inventata. Dopo un annetto, Wakefield ammise tutto (8).
Infine, farmaci efficaci possono essere ben sperimentati e immessi in commercio, ma essere destinati a una platea molto ristretta, ossia pazienti con condizioni cliniche estremamente particolari e/o ricchi che possono acquistare privatamente l’articolo.
Numerosi sono i farmaci cosiddetti “biologici”, nuove molecole prodotte con tecnologie sviluppate pienamente solo negli ultimi trent’anni e in continuo aggiornamento, che hanno esteso notevolmente la possibilità di guarigione e controllo delle malattie, soprattutto tumori e malattie autoimmuni. Il problema è che costano moltissimo: si stimano circa 15000 € annui per il trattamento dell’artrite reumatoide con biologici. Su questo pesa molto il fatto che queste nuove molecole, di cui aggiornamenti sempre più efficienti vengono realizzati anno dopo anno, sono coperte ancora quasi tutte dai brevetti, una delle vere zavorre della medicina, che durano vent’anni: la realizzazione di meno di una decina di “biosimilari” (i generici dei farmaci bio) ha fatto passare in qualche anno la proporzione tra farmaci biologici originatori e generici da 99%-1% a 60-40% - dati del 2018 (8) - segno di una delle tante possibilità per l’uomo di conseguire una migliore salute a cui si oppone l’avidità dei padroni.
Un esempio clamoroso è quello dei farmaci inibitori di Pcsk9, che abbassano il colesterolo in maniera eclatante: lo studio Fourier ha registrato una diminuzione del 60% nei livelli del «colesterolo cattivo» (le Ldl) rispetto alla precedente terapia ottimale (fondamentalmente, le comuni statine ad alte dosi), con una riduzione del 20% nella mortalità cardiovascolare, del 21% degli ictus e del 27% degli infarti cardiaci, a cui si unisce il bassissimo tasso di abbandono dello studio, che avviene solitamente per quei pazienti che subiscono degli effetti collaterali (9). Questi dati, comunque eclatanti di per sé, raggiungono un grado di unicità perché incidono sulla prima causa di morte al mondo. Purtroppo, anche in questo caso il costo attuale è di 15.000 € all’anno, cosicché essi sono indicati solo in pazienti con storia di infarto o ictus senza altre alternative terapeutiche o in rare ipercolesterolemie familiari. Il numero di morti evitabili stracciando il brevetto è uno dei dati più indicativi di cosa sia il capitalismo oggigiorno.
Dunque, condizionamento sugli indirizzi di ricerca, manipolazione dei dati e avidità nel dispensare cure: queste sono solo le categorie più ampie degli effetti funesti del capitalismo sulla scienza, in questo caso medica, che dunque effettivamente non è democratica.
Un’unica soluzione: controllo operaio sulla scienza
L’umanità, nell’ultimo secolo, ha allungato con dei ritmi impressionanti la speranza di vita, ma le disuguaglianze restano marcate (in alcuni Paesi africani essa è attorno ai 50 anni) e la qualità di vita non sta sempre al passo con il suo prolungamento. La tecnologia che il capitalismo ha sviluppato, resa possibile proprio dalla ricerca del profitto e dalla competizione tra i capitalisti, indisponibile per la gran maggioranza della popolazione e, intrappolata da logiche di arricchimento sempre più immediato, viene tarpata nel suo sviluppo. La pandemia che stiamo vivendo batte forte la campana del pericolo per la sopravvivenza dell’umanità e indica che è necessario liberare le risorse produttive e scientifiche al più presto.
Per estirpare le teorie antiscientifiche ed oscurantiste come quelle dei No Vax, verso cui i servi accademici dei padroni puntano il dito per nascondere la propria faccia dietro il braccio, è certamente necessario implementare l’istruzione complessiva, umanistica, scientifica e tecnica, del proletariato. Questa indicazione è il massimo che gli autori di saggi su questi temi riescono a partorire e rimane una vana litania in un sistema che va sempre più a tagliare sull’istruzione e ad asservire quest’ultima alla creazione di eserciti di giovani pronti all’immissione a basso costo sul mondo del lavoro, chiaramente precario.
Tuttavia, se questo magicamente avvenisse nel capitalismo, sarebbe un grosso problema per i padroni perché verrebbero più facilmente a galla tutte le sozzure con cui l’industria, la finanza e lo Stato corrompono la scienza. Dunque, costoro non chiedono l’istruzione, l’alfabetizzazione scientifica, la presa di coscienza, bensì qualcosa di decisamente antiscientifico: l’atto di fede.
La soluzione sta nel costruire per via rivoluzionaria un sistema in cui il proletariato tiene democraticamente le redini dell’economia e della politica, cosicché possa controllare anche la scienza. Non per sostituirsi ai professionisti e agli specialisti, ma per produrne di più, indirizzare il loro operato verso le necessità della popolazione e sorvegliare, istruiti, sulle loro azioni.
(1) https://www.medicalfacts.it/2018/11/30/scienza-democrazia/
(2) https://www.qeios.com/read/FXGQSB
(3) https://www.ilfoglio.it/economia/2019/11/14/news/ce-del-vecchio-allo-ieo-286704/
(4) https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/maxi-multa-per-eni-ha-ingannato-i-consumatori-sul-green-diesel/
(5) https://valori.it/vaccino-agnoletto-modello-big-pharma-non-funziona-dossier-covid/
(6) https://www.corriere.it/video-articoli/2017/05/01/manipolazione-ricerche-scientifiche-caso-alfredo-fusco-replica-professore-falsi-fatti-mia-insaputa/2fef942c-2e7c-11e7-8176-4e0249fd95d5.shtml
(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22336803/
(8) http://wakefieldgmctranscripts.blogspot.com/2012/02/gmc-fitness-to-practice-hearing-for.html
(9) http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/?p=571
(10) https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/fca-2017-0052