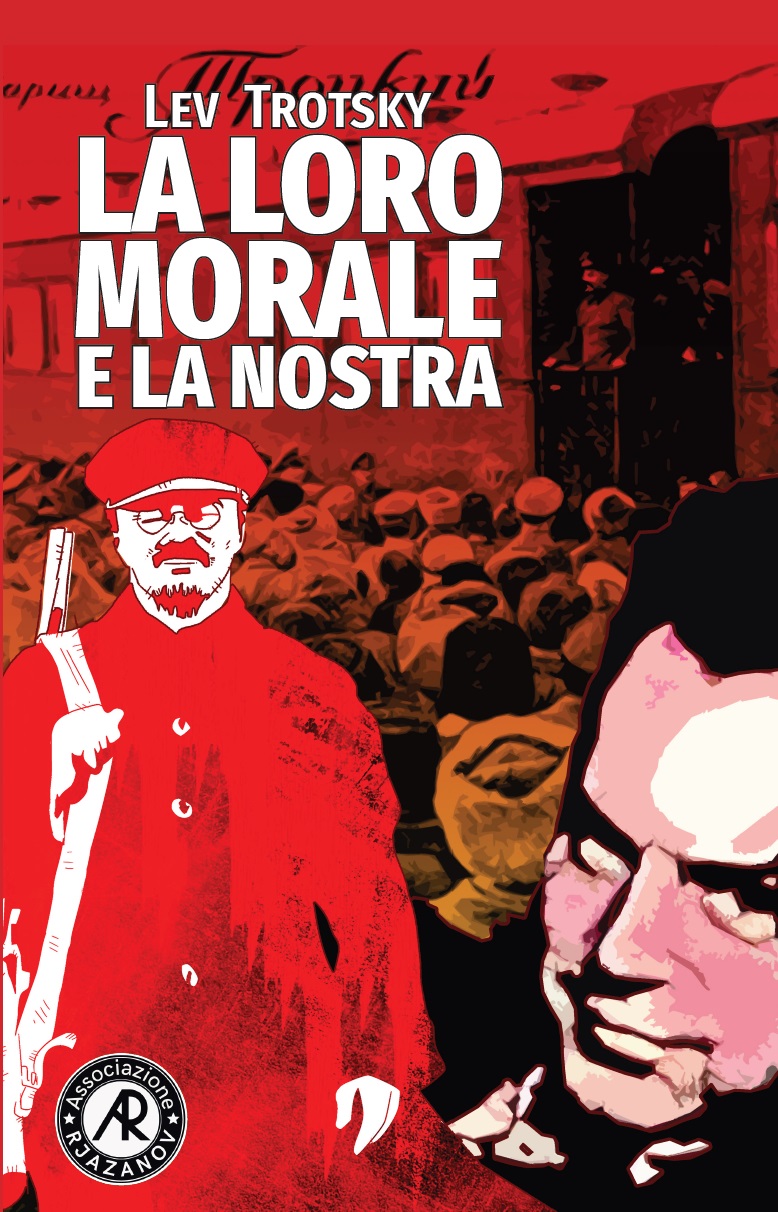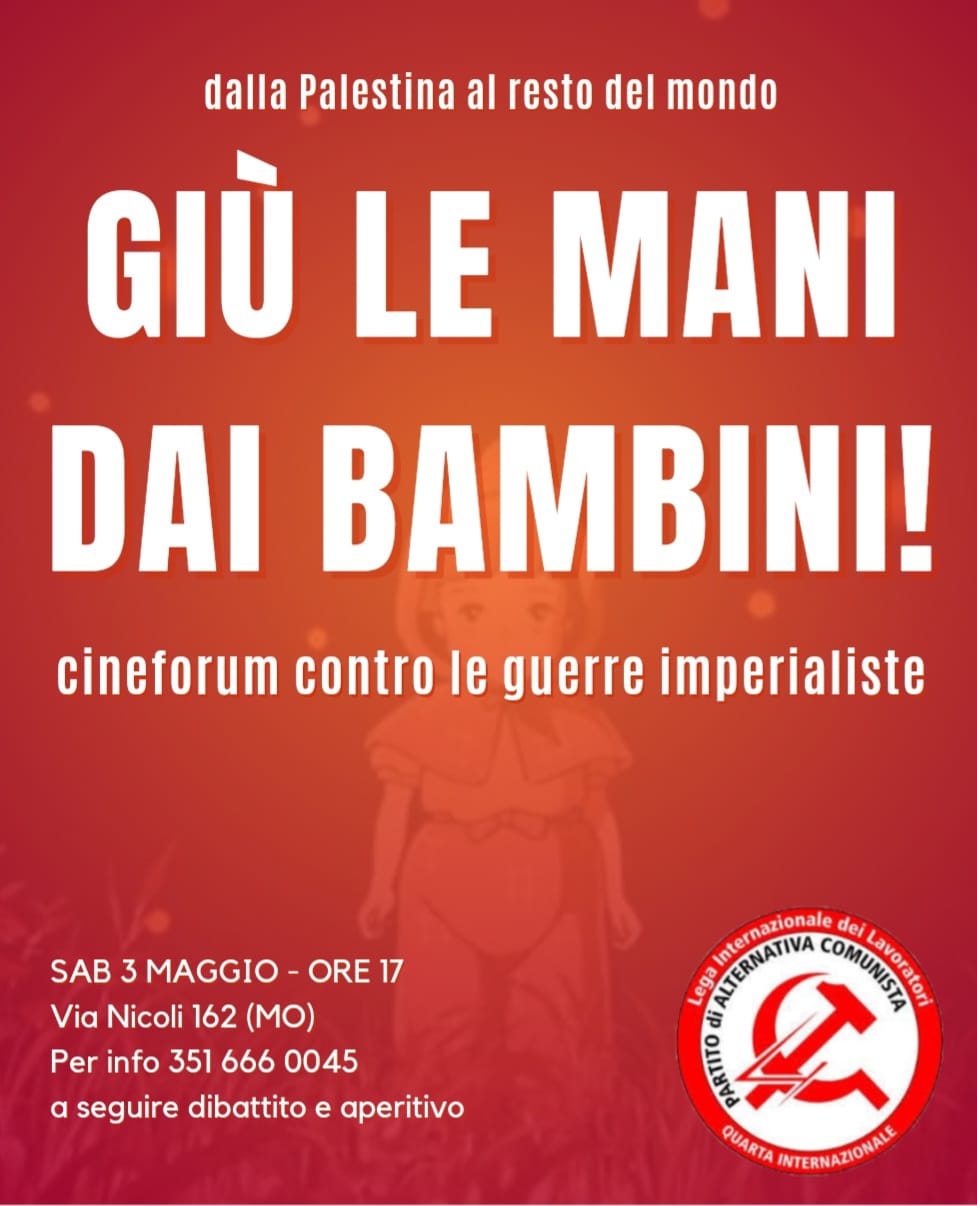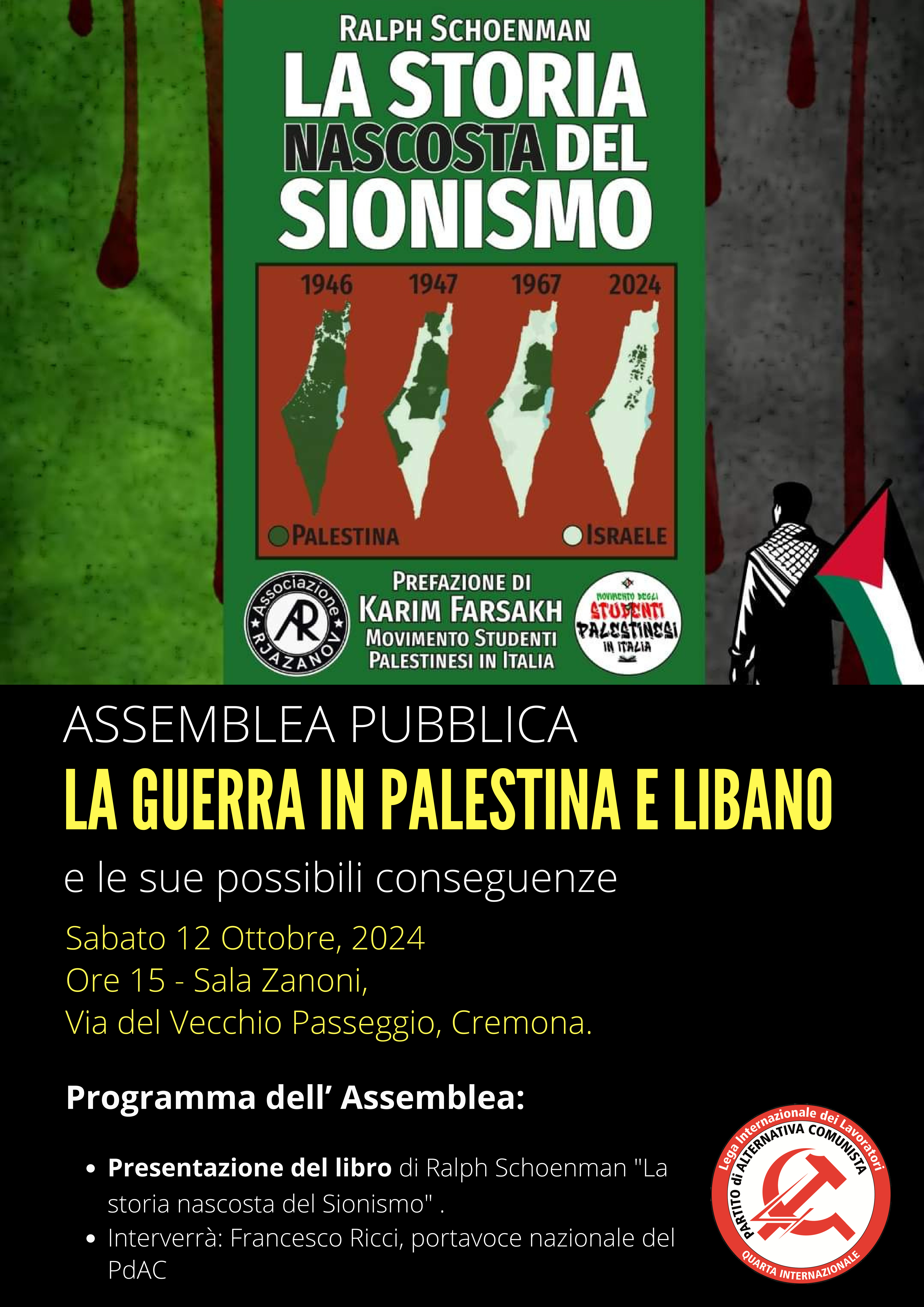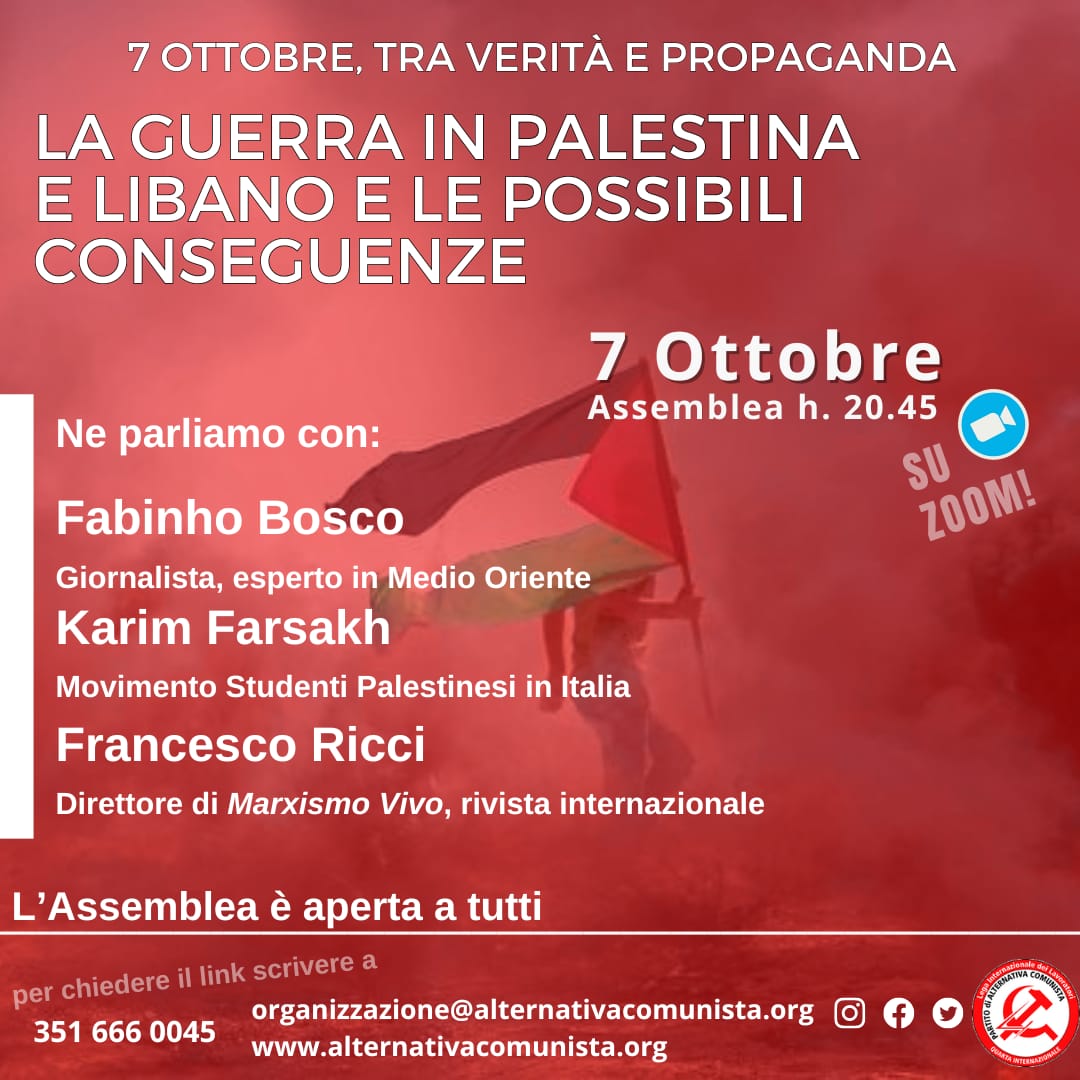Dalla lotta al partito delle lotte e del socialismo:
il passaggio fondamentale
di Diego Bossi (operaio Pirelli) (*)

«È in fabbrica che gli operai acquisiscono consapevolezza e imparano un sano odio di classe». Questa frase, con tutte le sue varianti che non ne cambiano la sostanza, l’avremo sentita decine di volte; è una frase semplice quanto vera, poiché un operaio, subendo lo sfruttamento padronale e vedendo altri operai nelle sue medesime condizioni, impara dalla sua esperienza diretta di vita vissuta i fondamentali della lotta di classe: la società è divisa in sfruttatori e sfruttati; gli operai, e più in generale i lavoratori salariati, sono sfruttati; gli sfruttati, quando si uniscono, hanno la forza di lottare e ottenere risultati importanti contro gli sfruttatori. È quindi sufficiente essere lavoratori per comprendere e assimilare le conoscenze necessarie per lottare contro i padroni? Basta essere operai per volerla fare questa benedetta lotta di classe? La risposta che noi diamo a queste due semplici domande è la risposta che sta sotto gli occhi di tutti: no. Ma qui è utile spiegare bene: la lotta di classe esiste, questo è un fatto inopinabile. Si può a diversi gradi averne consapevolezza e animarla, diverso è il discorso della consapevolezza politica e della lotta per il socialismo, che dev’essere portata nella classe dall’esterno tramite il partito.
A questo punto dovremmo concludere che la frase con cui è iniziato questo articolo non sia poi così vera visto che gli operai nemmeno con lo sfruttamento subìto imparano a ribellarsi contro il loro padrone. Ma anche questa conclusione sarebbe errata o quanto meno inesatta o, meglio ancora, incompleta, perché ad essere incompleto è il quadro iniziale: la fabbrica è sì propedeutica alla lotta di classe, ma la classe borghese a noi avversa e dominante, possiede una serie di strumenti importanti volti a controllare il conflitto di classe. Volete sapere quali sono questi strumenti? Verrebbe da rispondere che è sufficiente guardarsi intorno, perché ogni cosa che circonda i proletari nella loro vita lavorativa e sociale, è strumento borghese di prevenzione del conflitto di classe: la democrazia borghese e le sue istituzioni, la narrazione fiabesca sulla «Costituzione più bella del mondo», il diritto di voto presentato come soluzione pacifica e democratica di partecipazione alla politica, la Magistratura come giustizia imparziale nel far rispettare le leggi prodotte dal Parlamento eletto da tutti, i sindacati coi loro infiniti tavoli di trattativa col padrone, le sinistre riformiste che illudono la classe di poter migliorare il capitalismo dal suo interno per poi andare ai peggiori compromessi con la borghesia, le destre populiste che fanno leva sulle peggiori pulsioni sociali come razzismo, maschilismo e lgbtfobia per dividere il proletariato ad uso e consumo dei padroni, la propaganda ininterrotta dei media borghesi e così via per un’infinita serie di influenze che ogni lavoratore, nessuno escluso, subisce quotidianamente. Così il conflitto viene sedato, deviato, assorbito, represso e, sulla base dell'inconciliabilità degli interessi di classe tra lavoratori e padroni, parte e riparte mille e più volte; e mille e più volte si disperde fra le viscere del capitale, vanificando sforzi e ferite di guerra, deludendo sogni e ambizioni. Ed è così che ritorniamo nella nostra fabbrica, dove la semplicità e la nitidezza di ciò che insegna un’esperienza di vita diretta, si perde nelle fitte trame che la borghesia dispone per garantire il suo dominio e i suoi profitti.
«La cultura dominante è la cultura della classe dominante», scriveva Marx. È vero. È maledettamente vero. È talmente vero che oggi sono pochi, molto pochi, i lavoratori che riescono a sfuggire, anche solo parzialmente, alla cultura dominante: sono le avanguardie, coloro che la lotta di classe la dirigono e la combattono in prima linea, un’azione continua e ininterrotta verso quella parte maggioritaria di lavoratori che nella cultura dominante è rimasta intrappolata: ed è così che i padroni pensano come i padroni e gli operai pensano, anch’essi, come i padroni. E in questo contesto sconfortante le avanguardie, per tornare alla nostra frase di incipit, stanno in fabbrica e imparano l’odio di classe. Il problema è che la classe, spesso immobile e apparentemente incapace di reagire, che finiscono con l’odiare, è la loro.
È a questa eresia che siamo giunti e da questa eresia dobbiamo ripartire. Perché questa insolente affermazione ha il potere di arrivare alla pancia senza passare dalla testa, e di provocare un sorriso amaro di consapevolezza e rabbia a qualsiasi avanguardia operaia che la legga.
Ma noi dalla testa ci dobbiamo passare, e dobbiamo farlo utilizzando uno strumento potentissimo di pensiero e di analisi che Marx ci ha lasciato: il materialismo storico e dialettico.
Materialismo e idealismo: filosofie contrapposte per leggere il mondo
Premetto che non sono un esperto di filosofia e che qui cercherò solo di sintetizzare l’idealismo e il materialismo, cercando di offrire un’immagine della loro trasposizione nella vita concreta e nelle prospettive politiche.
Prima di parlare di materialismo occorre parlare di idealismo e fare un salto indietro negli anni in cui Marx era un giovane studente e all’università di Berlino i corsi di filosofia li teneva Hegel, tra le figure più rappresentative dell’idealismo tedesco.
Nella concezione Hegeliana esiste Dio. Di conseguenza la realtà tutta, per intero, incluse le sue contraddizioni, non è altro che la rappresentazione materiale e quindi imperfetta di qualcosa di esterno alla sfera materiale ma perfetto, cioè ideale. In sintesi: ogni cosa costituisce una rappresentazione concreta di una sua idea astratta. Marx ne «La Sacra famiglia», facendo riferimento a un frutto, spiegava che per la concezione hegeliana l’essenza di una pera non era la pera in sé, ma la rappresentazione astratta e ideale che abbiamo della pera, col risultato che ogni pera reale fosse una rappresentazione perfettibile in funzione della sua idea astratta.
Da questa concezione ne consegue quella dello Stato, che non rappresenta null’altro che “l’idea divina, così come essa esiste sulla Terra” (1). Dal punto di vista politico, Hegel non poteva dunque essere altro che un profondo reazionario, sostenitore dello Stato così come esso si presentava ai suoi tempi, tanto da considerare la monarchia costituzionale come la rappresentazione migliore dell’«idea divina». Se accettiamo il punto di vista di Hegel dello Stato come idea divina ne deduciamo, come ovvio corollario, che il massimo rappresentante dello Stato, il sovrano, è la rappresentazione materiale (seppur imperfetta) di Dio.
Per Hegel dunque le leggi costituivano delle prescrizioni divine e i loro esecutori venivano considerati come coloro che le applicavano nella società, consentendo alla società di funzionare come una rappresentazione, solo perfettibile, del mondo ideale.
Se dunque lo Stato è l’oggettivazione dello spirito nella storia allora gli uomini devono obbedire alle sue leggi e la loro azione consiste solo nel migliorarlo, nel superarne progressivamente le contraddizioni. Ma queste contraddizioni non sono per Hegel la conseguenza della divisione in classi della società perché non è di Hegel l’introduzione del concetto di classi. Le contraddizioni sono la differenza tra la pera reale e l’idea di pera, per dirla con Marx, cioè derivano dal fatto che la società reale rimane una rappresentazione della società ideale e quindi come la pera reale essa assomiglia alla pera ideale ma non lo è. Le leggi sono conseguentemente perfettibili in modo da rendere la società sempre più giusta e più armonica, sempre più simile all’idea divina, per intenderci.
La traduzione politica di questo pensiero è il riformismo, basato sulla sacralità e il feticcio delle istituzioni borghesi (2) che tenta di superare, attraverso la ragione, le contraddizioni che esistono nello stesso Stato. Per essere onesti fino in fondo bisogna poi ricordare che il gradualismo riformista non ha avuto presa solo sul pensiero liberale, essendo stato introdotto dagli stessi marxisti revisionisti, come Bernstein o Jaures, all’interno del movimento operaio e ha rappresentato dal punto di vista teorico, probabilmente, il principale virus che ha infettato la II Internazionale. Sia per i liberali discendenti da Hegel sia per i marxisti revisionisti, dunque, non vi è rivoluzione sociale, ma solo graduale transizione verso uno Stato sempre più giusto, più equo e più libero.
Da una parte la rivoluzione è esclusa dallo stesso impianto teorico idealista, dall’altra l’idealismo produce quella narrazione attendista che è un vero e proprio tratto distintivo dei partiti riformisti e delle grandi burocrazie sindacali. Abbiamo tutti sentito infinite volte nel corso delle nostre lotte frasi come: «dove vogliamo andare con questa classe operaia?», «gli operai non si muovono più come una volta, pensano solo allo smartphone e al campionato di calcio», «prima della rivoluzione ci vuole una rivoluzione culturale», «altro che sciopero… con questi rapporti di forza dobbiamo andare a trattare e cercare di portare a casa il meno peggio», potremmo andare avanti per ore, il messaggio da veicolare è chiaro: nel frattempo che i lavoratori arretrati e acritici acquisiscano la consapevolezza di classe necessaria alla lotta (cioè si liberino dal loro elemento ideale), state tranquilli, ci pensiamo noi, che in questo quadro sociale e politico incompatibile con la lotta di classe, dovremo affidarci al tavolo di trattativa col padrone e col governo, al tribunale, alla contrattazione collettiva e a tutti quegli strumenti che l’ordinamento democratico borghese mette a disposizione. Che sono poi gli strumenti fuori dal controllo dei lavoratori perché sono nelle mani esclusive delle burocrazie; ma, soprattutto, sono quegli strumenti che dirimono il conflitto sociale e lo deviano verso mete che la borghesia può digerire ed espellere con un rutto. Oltre al danno la beffa, potremmo dire; perché non solo così la sinistra riformista e le burocrazie sindacali trovano l’alibi per non veicolare la rabbia dei lavoratori alle naturali conseguenze rivoluzionarie, ma quell’alibi sono i lavoratori stessi a cui scaricano la responsabilità dei fallimenti di quelle stesse burocrazie sindacali che in questo modo cercano di occultare il loro tradimento doloso e consapevole verso milioni di proletari.
Questo è ciò che sta avvenendo negli ultimi trent’anni (3), dove noi lavoratori, come nel Monopoli, ripassiamo dal via, ma ogni volta che passiamo le venti euro le perdiamo anziché guadagnarle. Rifacciamo sempre lo stesso ciclo e giro dopo giro, governo dopo governo, contratto dopo contratto, accordo dopo accordo, ci ritroviamo nello stesso punto più poveri e più deboli.
Sorge spontanea la domanda: ma in questo percorso circolare non c’è un modo per evitare questo costante esito distruttivo per noi? No, se continuiamo a percorrere il sentiero senza una prospettiva socialista, perché comunque la si voglia vedere, qualunque cosa ci vogliano raccontare e qualsiasi cosa vogliamo illuderci di credere, gli interessi degli operai e quelli dei padroni andranno sempre in direzioni opposte. E il conflitto, nuovamente, partirà e ripartirà mille e più volte; e ancora mille e più volte si disperderà tra le viscere del capitale.
Non abbiamo altra scelta che marciare sul sentiero con l’obiettivo di costruire un sistema economico e sociale non più basato sullo sfruttamento di tanti nell’interesse di pochi. È a questo punto che Marx ci offre una prospettiva che stravolge l’idealismo hegeliano contrapponendo ad esso il materialismo. Sia chiaro: il materialismo non è un’invenzione di Marx, ma fu Marx per primo a estrapolarlo dall’individuo per applicarlo alle classi sociali, alla loro collocazione nei rapporti di produzione e ai processi storici, e fu sempre Marx ad applicare ad esso la dialettica. Ma in soldoni, in cosa consiste il pensiero materialista? Per semplificare possiamo dire che mentre per gli idealisti lo spirito, ossia l’elemento ideale, è il fattore da cui scaturisce la società nei suoi assetti economici e politici, per i materialisti, al contrario, sono le circostanze materiali e i rapporti di produzione a fare l’uomo nelle sue dimensioni sociali e politiche.
Marx scriveva: «Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita, non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la coscienza» (4), e ancora: «l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini» (5). La portata di questa concezione è forte, importante e rivoluzionaria, perché dopo aver creduto per una vita che fosse il camaleonte a trasmettere il suo colore alla foglia, ci viene svelato che, al contrario, è il camaleonte a ricevere il colore della foglia su cui poggia. Uscendo dalla metafora per trarre conclusioni logiche e concrete nella militanza quotidiana delle nostre avanguardie, diciamo che noi non dobbiamo cambiare
l’umanità per cambiare il mondo, obiettivo chiaramente irrealizzabile; ma dobbiamo cambiare il mondo (il suo sistema economico e i suoi rapporti di produzione nda) per cambiare l’umanità. E a questa concezione rappresentata dal materialismo storico, Marx aggiunge la dialettica, escludendo qualsiasi dinamica meccanicistica o deterministica nei processi storici, spiegando che la coscienza non è un pezzo di legno trasportato dalla corrente del fiume, incapace di reagire agli eventi, ma che appunto tra uomo e circostanze – tra classi, per meglio dire – esiste un rapporto dialettico in costante movimento. Il capitalismo non è un punto d’arrivo definitivo e immutabile della società, non è eterno, i lavoratori che acquisiscono la consapevolezza e la coscienza di classe possono e devono rovesciarlo. E questa coscienza può essere trasmessa alle avanguardie operaie solo dall’esterno, tramite un partito che porti il socialismo nelle lotte per portare le lotte al socialismo.
Il materialismo storico e dialettico, in sintesi, ha tre meriti importanti: 1) condurci alla prospettiva rivoluzionaria senza scuse o alibi, poiché, per cambiare la società, è necessario cambiare il sistema economico e i rapporti materiali di produzione, ed necessario lavorarci da subito, senza aspettare che la classe operaia sia consapevole e pronta alla guerra, perché questa consapevolezza crescerà proprio nel corso della guerra; 2) dare una spiegazione scientifica e filosofica all’arretratezza della classe, le nostre avanguardie non devono demotivarsi davanti ai lavoratori inerti e abulici, poiché questa ignavia è l’effetto di una malattia causata dal capitalismo, non la causa che impedisce di rovesciarlo; 3) impostare la rotta verso il rovesciamento di questo sistema che non è immutabile, guidando le masse a prendere parte attiva nel loro rapporto dialettico con il sistema economico e produttivo e ad esprimere l’ineludibile conflitto di classe.
Detonare il conflitto e dirigerlo verso il socialismo: il compito più importante delle avanguardie
Nel 1994 prestai servizio militare nel Genio guastatori, imparai in quei mesi ad assemblare cariche esplosive al tritolo. I militari di professione ci dissero che gli elementi dell’ordigno erano tre: la miccia, il detonatore e l’esplosivo. Il tritolo – spiegarono nelle lezioni teoriche in aula – è un esplosivo «sordo», vale a dire che si può anche scaraventarlo per terra con tutta la forza, calpestarlo, incendiarlo, ma questo non esploderà perché è, appunto, sordo.
L’unico modo per fare esplodere il tritolo è tramite un detonatore, cioè un cilindretto grande come mezza sigaretta da inserire molto lentamente (il detonatore è tutt’altro che «sordo»: basta un movimento brusco ed esplode) nella carica di tritolo. In pratica il tritolo esplode solo tramite un’altra esplosione al suo interno. Infine entra in gioco il terzo elemento: la miccia, questo cavo scintillante che, inserito nel detonatore, causa la deflagrazione della carica. Da qui possiamo fare almeno tre deduzioni importanti: 1) la miccia collegata a un detonatore non inserito nel tritolo farebbe esplodere solo il detonatore: un piccolo scoppio pari a quello di un petardo che non nuoce a nessuno; 2) la miccia collegata al tritolo senza un detonatore non sortirebbe alcun effetto perché il tritolo è «sordo» e rimane inerte a qualsiasi stimolo ad eccezione di una detonazione; 3) l’unico modo per portare a buon fine la deflagrazione della carica è che la miccia arrivi al detonatore e che il detonatore sia inserito nel tritolo. In assenza di queste due condizioni non vi sarà alcuna esplosione.
Proviamo ora a traslare questo meccanismo nelle dinamiche della lotta di classe. La miccia è rappresentata da qualsiasi movente possa potenzialmente attivare la rabbia sociale e il tritolo sono le masse popolari e i lavoratori. Da subito possiamo affermare con assoluta certezza che questi due elementi ci saranno sempre: nel capitalismo ci sarà sempre un motivo di conflitto tra lavoratori e padroni poiché i loro interessi sono inconciliabili, al contempo, ci sarà sempre una società divisa in classi fra loro contrapposte, quindi esisteranno sempre le masse proletarie oppresse dalla borghesia. Qual è l’elemento la cui presenza non possiamo dare per scontata? Il detonatore, o meglio i detonatori, vale a dire le avanguardie di lotta in grado di raccogliere le infinite «micce» offerte ogni giorno dal conflitto di classe e tradurle in una detonazione all’interno delle lotte. Tornando alla nostra metafora dell’esplosivo e alle tre deduzioni di cui sopra, possiamo dire che non sortirebbe alcun effetto una qualsiasi situazione di sfruttamento e di repressione se quest’ultima non venisse colta da un’avanguardia operaia e tradotta in una rispettiva lotta di contrasto all’offesa ricevuta (la miccia che va direttamente al tritolo senza un detonatore); né produrrebbe risultati utili se la situazione di sfruttamento fosse sì colta da un’avanguardia, ma quest’ultima non fosse ben inserita tra i lavoratori, magari perché li ritiene troppo arretrati e passivi per dedicarci del tempo a fare politica con loro, ma così facendo si troverebbe isolata e impossibilitata a costruire e dirigere una lotta (la miccia collegata a un detonatore non inserito nella carica di tritolo). L’unico modo per mettere in campo una lotta è avere delle avanguardie presenti e inserite nella classe operaia, in grado di riconoscere lo sfruttamento, raccontarlo ai lavoratori, sviluppare una lotta e dirigerla (la miccia in un detonatore inserito nell’esplosivo).
Ma tutto questo ancora non basta, perché di lotte se ne sviluppano centinaia di migliaia ogni giorno in tutto il mondo. Il punto cruciale rimane l’obbiettivo finale di queste lotte, la direzione che seguono e quanto esse siano coordinate fra loro.
È ora di affrontare la questione più importante: il passaggio necessario da avanguardie operaie a militanti rivoluzionari.
Partito, programma, metodo, militanza: elementi fondamentali nell’intervento dei rivoluzionari nei sindacati
Come abbiamo visto il ruolo delle avanguardie di lotta è fondamentale per lo sviluppo del conflitto di classe, un quadro operaio capace è in grado di conquistare la fiducia dei lavoratori, ma questa fiducia spesso viene accordata verso direzioni riformiste pronte a tradirla, portando le lotte verso il fallimento e il compromesso di classe con la borghesia.
Le grandi burocrazie sindacali concertative, strumento della sinistra riformista e borghese, vedono il centro della loro azione sindacale nella trattativa col padrone, nel rapporto dare/avere tra le parti, ma come abbiamo spesso sottolineato, nel capitalismo, la concertazione è subordinazione al capitale: non esistono interessi comuni sul quale convergere, per questo non è possibile concertare col padrone, perché esso nella trattativa perseguirà i suoi interessi e corromperà le burocrazie riformiste per farli digerire ai lavoratori; di qui muove il dovere dei rivoluzionari di intervenire nei sindacati e nei movimenti e di contrapporsi sempre, senza esclusione di colpi, alle direzioni riformiste, perché esse cercheranno sempre di riformare il capitalismo senza rovesciarlo, e lo faranno col solo e unico scopo di contrattare con la borghesia e coi suoi governi l’olio per lubrificare gli ingranaggi delle loro burocrazie. Per fare questo non solo non dovranno cercare la rivoluzione, seguendo altre strade, ma dovranno attivamente fare il possibile affinché non avvenga: mentre noi siamo per la democrazia operaia e la partecipazione dei lavoratori, per la conquista di salari dignitosi e diritti democratici, loro sono per la delega in bianco suggellata da votazioni farsa su compromessi al ribasso; mentre noi siamo per la solidarietà di classe e il fronte unico per unire le lotte, loro sono per la separazione di vertenze circoscritte in compartimenti stagni; mentre noi siamo per organizzare i militanti affinché abbiano un’influenza di massa e per il protagonismo del proletariato, loro sono per il settarismo e l’autoreferenzialità delle burocrazie; mentre noi siamo per un partito internazionale di avanguardie, per loro l’internazionalismo è, tutt’al più, un confronto tra burocrati provenienti da Stati diversi. Mentre noi siamo per il potere dei lavoratori, loro sono per il potere della borghesia.
Per dirla con Trotsky, i sindacati o sono diretti dai rivoluzionari e diventano strumento per la rivoluzione, o sono diretti dai riformisti e diventano strumenti della borghesia all’interno del proletariato.
È sulla base di questo ampio preambolo che arriviamo alla necessità costruire l’unico strumento in grado di liberare l’umanità da un sistema criminale che sta distruggendo il pianeta e affamando miliardi di persone: un partito che abbia un programma, lo attualizzi calandolo nella lotta di classe e lo applichi attraverso un metodo che ne eviti la dispersione.
La prima considerazione da fare, la più importante che sta a monte di tutto, è che il capitalismo è un sistema mondiale e centralizzato e che la borghesia, in quanto classe dominante, dispone di governi, tribunali, eserciti e parlamenti. Solo se riusciamo a comprendere bene le dimensioni, la struttura organizzativa e le potenzialità di attacco del nemico che sta dall’altra parte della linea di classe, potremo comprendere quale strumento sarà necessario per rovesciarlo e prendere il potere: la rivoluzione non si fa coi comitati di buoni intenti, la rivoluzione si fa contrapponendo al potere della classe dominante un potere parimenti centralizzato e internazionale: il partito.
Ed è sul partito che qui voglio evidenziare alcuni aspetti centrali e proporre alcune riflessioni.
In primo luogo voglio scrivere con l’inchiostro indelebile quella che credo sia una grande verità: un rivoluzionario è tale solo all’interno del partito, perché rivoluzionario è il partito e una persona può esserlo nel senso compiuto del termine solo come militante impegnato nella costruzione dello stesso, poiché per essere rivoluzionari non basta la conoscenza teorica né la sola indole alla lotta di classe. Per noi teoria e prassi si auto-alimentano reciprocamente in un rapporto dialettico, nell’ambito di una elaborazione programmatica internazionale; e tutto ciò è possibile solo all’interno di un partito. Per essere rivoluzionari non è sufficiente volerla fare, la rivoluzione: è necessario lavorare quotidianamente nella costruzione dello strumento che può guidarla alla vittoria.
In secondo luogo vi è la questione dell’internazionale, che non va vista come un soggetto collegato al partito, una risorsa di cui il partito dispone e a cui il partito aderisce per coordinarsi con altri partiti nel mondo. L’internazionale per noi è il partito e i partiti nazionali ne sono le sezioni. Separare partito e internazionale è come mettere una virgola tra il nome e il cognome, cioè tra due elementi di uno stesso soggetto.
La terza questione riguarda il programma, che per noi è un programma di transizione dal capitalismo al socialismo, che accompagna i lavoratori nelle loro lotte per le rivendicazioni salariali e per i diritti democratici e li guida verso una società libera dal profitto, perché solo quando i lavoratori prenderanno il potere espropriando i mezzi di produzione alla borghesia, sostituendo lo Stato borghese con lo Stato operaio, le loro lotte potranno giungere a una vittoria completa e definitiva.
Quarto aspetto: il metodo. I rivoluzionari intervengono nei sindacati e nei movimenti rispettando la democrazia operaia, unica vera arma contro le burocrazie riformiste. Se da una parte rimane costante il nostro impegno nel cercare di orientare i lavoratori al conflitto sociale per passare dalla lotta sindacale a quella politica, dall’altra rimane tassativa la pratica dell’educazione alla partecipazione attiva e al rispetto delle decisioni prese nelle assemblee, fattore, quest’ultimo, che non può e non deve essere subordinato al nostro lavoro di orientamento politico. Perché per noi è di estrema importanza conquistarci la fiducia dei lavoratori, far vedere loro che rispettiamo sempre le decisioni prese nelle assemblee. I comunisti non devono mai nascondersi e mai devono rinunciare a spiegare alla classe le loro posizioni, al contempo non devono cercare scorciatoie per raggiungere i loro obiettivi programmatici. L’inconciliabilità degli interessi di classe si tradurrà nell’esplosione di altri conflitti riportando nuovamente i lavoratori da noi; così anche il tradimento delle direzioni riformiste ci riporterà davanti ai lavoratori delusi e in cerca di un riferimento. A quel punto l’unica differenza la farà il comportamento che avremo tenuto nel corso delle lotte, la nostra trasparenza e il rispetto delle decisioni, anche quelle non particolarmente avanzate, che avremo avuto nei confronti della classe. Diversamente al nostro intervento all’esterno, per quanto riguarda il funzionamento interno al partito utilizziamo il metodo del centralismo democratico. Sulla questione non mancano le critiche, che per semplificare potremmo dividere in due categorie: le critiche che arrivano dagli anarchici, che mal sopportano il centralismo; e le critiche che arrivano da riformisti e stalinisti, che mal sopportano la democrazia.
Gli anarchici sono contro il partito, pertanto non accettano nessuna subordinazione dell’individuo all’organizzazione. La risultante è la perdita di efficacia nelle azioni discusse e nell’attuazione delle linee programmatiche: liberi tutti, nessun potere, ma quando si tratta di agire, non solo nessuno è vincolato all’azione, ma ognuno può continuare ad andare nella direzione che crede, anche se questa è difforme da quella della maggioranza.
Riformisti e stalinisti devono avere il controllo degli apparati burocratici che dirigono e una reale democrazia all’interno delle loro organizzazioni non giocherebbe a loro favore; e questo meccanismo si estende fisiologicamente nel loro intervento tra i lavoratori, perché l’unica moneta di scambio che possono offrire alla borghesia è il controllo della classe lavoratrice. Per questo motivo i partiti riformisti e le burocrazie sindacali confederali, alla democrazia operaia contrappongono il modello di democrazia borghese, dove il voto non è decisione collettiva ma ratifica acritica e pilotata delle decisioni prese dalle direzioni e la partecipazione lascia il posto alla delega in bianco. I comunisti rivoluzionari promuovono e applicano la democrazia operaia tra i lavoratori e il centralismo democratico nel partito.
Il metodo del Centralismo democratico è la perfetta congiunzione tra democrazia per decidere e capacità operativa per attuare le decisioni prese, perché una decisione presa e non attuata è antidemocratica tanto quanto una decisione imposta.
Per spiegare questo metodo di funzionamento che regola le dinamiche del partito di tipo bolscevico, potremmo dire che il centralismo democratico si articola in tre fasi: 1) discussione e confronto libero nei momenti che precedono una votazione; 2) allineamento di tutto il partito alle decisioni prese dalla maggioranza; 3) bilancio sulle decisioni prese e attuate.
Quinta ed ultima questione, la più importante poiché è onnicomprensiva, è la militanza. Questa parola deriva da «militare», un termine che può piacere poco come sostantivo, riconducendo a soldati dell’esercito borghese (i militari dell’Arma…); piace sicuramente di più come aggettivo, dando idea di buon funzionamento e di rigide norme (un’organizzazione militare…); ma è sicuramente preferibile ad ogni altra accezione come verbo (militare in un partito…) perché noi militiamo, non intendiamo l’attivismo politico come volontariato nel tempo perso. La militanza è l’unico modo che ha un lavoratore per dare sostanza alla lotta di classe, coerenza tra teoria e prassi e prospettiva programmatica orientata verso il socialismo. Ogni militante diviene più di sé stesso, abbandonando il suo stato di soggetto individuale, tutt’al più coordinato in qualche organizzazione, per diventare un organo del partito che esso stesso costruisce.
Dei tre criteri leninisti del partito bolscevico (programma, militanza e autofinanziamento), che è l’unico partito che nella storia ha portato a termine vittoriosamente una rivoluzione socialista, la militanza è l’unico, come dicevo, onnicomprensivo, vale a dire che non può sussistere senza gli altri due criteri poiché li comprende, li ingloba a sé. Infatti sono possibili casi di autofinanziamento senza militanza, è il caso delle organizzazioni filantropiche o, più in generale, dei tesseramenti passivi che caratterizzano i partiti di massa, spesso si tratta di oboli corrisposti per lavarsi la coscienza; altrettanto possibile è la condivisione programmatica fine a sé stessa, senza impegno, anch’essa peculiare dei partiti riformisti e centristi; ma non esiste militanza senza condivisione programmatica e autofinanziamento: nessuno milita in un’organizzazione se non ne condivide gli scopi e nessun militante si astiene dall’autofinanziare la propria organizzazione. Sarebbe semplicemente una contraddizione in termini.
Questo è il partito che cerchiamo di costruire: non un’organizzazione di massa, ma un’organizzazione che eserciti influenza sulle masse tramite i suoi quadri e i suoi dirigenti rivoluzionari, che possono rimanere tali, evitando il dissolvimento nelle aree più arretrate della classe, solo all’interno di un partito che abbia una delimitazione programmatica e organizzativa. Noi siamo per l’unità d’azione contro il nemico di classe, non per l’unità di partiti con programmi diversi.
Ogni tassello è fondamentale e necessario
Ho pensato molto a quale tema affrontare in conclusione di questo articolo, il finale è sempre la parte più importante, forse perché è più soggetta a permanere nella testa del lettore, oppure perché in qualche modo narra gli aspetti più importanti, tira le conclusioni di un percorso.
Dopo aver spiegato perché un’avanguardia di lotta non debba demoralizzarsi di fronte all’arretratezza di classe, chi e cosa si nasconde dietro all’idealismo e quale risposta dà il materialismo storico e dialettico, quale ruolo e quale tattica debbano avere le avanguardie nella direzione di una lotta affinché essa si sviluppi proficuamente, perché serve un partito di quadri operai con influenza di massa, quali sono i requisiti del partito che serve, quale metodo debba regolarne le dinamiche interne, quale metodo dobbiamo adottare nel nostro intervento nei sindacati e nei movimenti, con quale programma percorriamo la strada verso il socialismo, credo sia importante affrontare una questione che, sulla base della mia esperienza di operaio che da anni pratica la lotta di classe, emerge con costanza e prevalenza tra i lavoratori, anche quelli più avanzati: la distanza dalla rivoluzione. Perché la rivoluzione è percepita come qualcosa che avverrà in un futuro indefinito. Questa percezione della rivoluzione socialista, oltre a scoraggiare i più dal perseguirla assiduamente, è a sua volta frutto di una concezione profondamente sbagliata e fuorviante.
Non starò qui a spiegare come anche chi la rivoluzione la fece non ne presagì fino a poco prima l’imminenza, né potrò analizzare le dinamiche virtuose di contagio e di espansione della lotta di classe (basti vedere le piazze del Sudamerica, di Francia e Catalogna): c’è chi sulla nostra stampa lo fa quotidianamente e direttamente dai teatri rivoluzionari o pre-rivoluzionari.
Ciò che credo sia importante in questo saggio sulla nostra internazionale rivolto alle avanguardie operaie in lotta, è demolire la visione della rivoluzione solo come un preciso evento circoscrivibile temporalmente. La rivoluzione è un processo storico che passa per la presa del potere. Ma basta la rivoluzione in un solo Stato? E allora in quanti e quali Stati dovremo prendere il potere per poter dire che avremo fatto la rivoluzione? E una volta preso il potere avremo finito? Dopo una rivoluzione politica non ne servirà una economica che esproprierà i mezzi di produzione alla borghesia? Dopo una rivoluzione economica non ne servirà una sociale che abituerà l’umanità a liberarsi dalla cultura capitalistica? Gli Stati operai dovranno essere eterni o dovranno estinguersi con l’estinzione delle classi fino a quando ognuno darà in base alle sue possibilità e avrà in base alle sue necessità?
Sono tutte domande che per noi comunisti hanno una risposta, ma sono domande che insieme formano esse stesse la migliore spiegazione della rivoluzione: un processo dinamico e dialettico in cui la presa del potere è una tappa fondamentale e ineludibile, non un evento statico e circoscritto che arriva con l’allinearsi dei pianeti. Un processo fatto di traguardi che a loro volta sono punti di partenza.
La rivoluzione parte dalle lotte di oggi ed è possibile ovunque, non è esclusiva di una futura era degli eroi. Come sarà il mondo nel socialismo, quali problemi dovremo affrontare, di quali altri strumenti dovremo dotarci, non possiamo saperlo nemmeno noi. Ma sappiamo benissimo cos’è il sistema economico capitalista, dove una minoranza di ultra miliardari sta spingendo l’intera umanità giù da un precipizio e sta devastando l’intero pianeta. Miliardi di persone lottano per sopravvivere ingrassando i profitti di una classe dominante.
La rivoluzione possiamo iniziare a costruirla da subito, dobbiamo scegliere se farlo o meno: nessun campionato si vince solo con la partita finale; nessuna partita la vince solo chi segna il goal! Ogni tassello è il tassello necessario e fondamentale a completare il mosaico.
Il compito dei comunisti rivoluzionari è quello di portare la lotta di classe verso la rivoluzione: ogni lotta, ogni singola lotta, se diretta dal partito rivoluzionario internazionale, cessa di essere una battaglia fine a sé stessa, e diviene un pezzetto di rivoluzione.
Questo è l’invito che noi facciamo a tutte le avanguardie di lotta di tutti i Paesi: venite a conoscere la Lega internazionale dei lavoratori – Quarta internazionale.
Aderite alla LIT-CI aderendo alle sue sezioni nazionali, aiutateci a costruire il partito rivoluzionario che serve; perché, citando Lev Trotsky, che fu tra i principali dirigenti fondatori della Quarta internazionale, «Ogni rivoluzione è impossibile… finché non diventa inevitabile».
(*) Un ringraziamento speciale ai compagni Salvatore De Lorenzo e Francesco Ricci per il loro prezioso quanto necessario aiuto, senza il quale non avrei potuto offrire ai lettori la qualità e la correttezza teorica che meritano.
Note
(1) Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia.
(2) Per Hegel la società non era divisa in classi, la scoperta delle classi sarà successiva e da ascriversi, come dirà Marx, agli intellettuali borghesi che si formarono durante la Rivoluzione francese.
(3) Dal 1993 è stata abolita la cosiddetta scala mobile, strumento di difesa dei salari dall’erosione dell’inflazione e di tutela del potere d’acquisto.
(4) Tratto da Per la critica dell’economia politica.
(5) Tratto da Il Capitale, libro I